You are currently browsing the category archive for the ‘Letture’ category.

E’ uscito per le edizioni CLEAN il mio nuovo libro, il titolo è “Le dimensioni della terra”. E’ una raccolta, come dice il sottotitolo, di letture sul territorio rurale, il paesaggio, la città. In qualche modo una sintesi delle cose che ho cercato di approfondire e comprendere in questi ultimi trent’anni. Ecco l’introduzione.
Gli scritti raccolti nel volume riguardano il mio lavoro: faccio l’agronomo, mi occupo di suoli, terre, paesaggi, della cura e del governo del territorio rurale. Come dice il sottotitolo, non si tratta di testi specialistici, di un resoconto tecnico delle cose di cui mi occupo, quanto piuttosto di letture.
Esercitare questo tipo di lavoro in Campania, in Italia; superare ogni giorno le difficoltà e i problemi che si presentano, è più difficile, direi impossibile, senza un’attività collaterale, continua, di riflessione sui presupposti e gli obiettivi del proprio operare, e un impegno deliberato per raccontare e condividere nel dibattito pubblico tutto questo.
Dalle attività di riflessione e divulgazione nascono quindi i testi riuniti in questo libro. Seppure diversi tra loro per lunghezza, strutturazione, linguaggio, essi vengono proposti come letture: oltre l’aspetto conoscitivo, informativo, certamente importante, l’obiettivo è anche quello di proporre e condividere storie, racconti la cui lettura offra, si spera, aspetti di curiosità e piacevolezza disinteressata.
Il racconto inedito con il quale il volume si apre è stato scritto nell’arco di alcuni mesi, a partire dal dicembre del 2012, ed è il nucleo iniziale attorno al quale il libro si è formato. È una sintesi in forma narrativa di tante e disordinate letture sull’origine, l’evoluzione e il funzionamento dei paesaggi rurali mediterranei, con uno strano andamento a ritroso, fino alle soglie della storia, partendo però dall’oggi, dalle cose che questi delicati sistemi ecologici e sociali tentano ancora strenuamente di comunicarci.
Il secondo testo è una riflessione, anch’essa inedita, scritta mentre il libro si andava componendo, su come è cambiato l’uso delle terre d’Italia nell’ultimo secolo e mezzo, dall’unificazione politica del Paese a oggi. Il modo con il quale le superfici agricole, forestali, urbane cambiano nel corso del tempo racconta molto di noi e della nostra storia. L’obiettivo era quello di suggerire una possibile periodizzazione, in vista di approfondimenti di maggior respiro; ma anche quello di sollecitare una maggiore consapevolezza delle urgenze del periodo che stiamo vivendo, assolutamente necessaria per elaborare strategie adeguate di governo delle terre e dei paesaggi d’Italia in questo primo scorcio di millennio.
La terza lettura è la rielaborazione di un saggio divulgativo scritto per un volume a tiratura limitata edito nel 2022 dall’Istituto della Enciclopedia Italiana “Treccani”, dedicato alla Campania. È una riflessione sui rapporti di lunga durata tra territorio rurale e città in questa bella e complicata regione d’Italia, dall’antichità, sino al disordinato mosaico contemporaneo nel quale la nostra vita si svolge.
Viene poi uno scritto di quasi vent’anni fa, che da allora non ha smesso di accompagnarmi, perché contiene la traccia e i riferimenti vitali di molte delle attività che mi sono trovato a svolgere poi: è un viaggio attraverso le differenti letture che tre grandi interpreti della questione meridionale – Antonio Genovesi, Giustino Fortunato, Manlio Rossi-Doria – nell’arco di un paio di secoli hanno fatto del capitale naturale, del patrimonio di risorse territoriali di cui dispone il Mezzogiorno d’Italia.
Quello che mi interessava era ragionare assieme a loro sulla natura relazionale e dinamica del concetto di “risorsa”, qualcosa che sta all’interfaccia tra i caratteri e i funzionamenti delle terre e degli ecosistemi da un lato, e le capacità, i bisogni e i valori delle società che li abitano e li utilizzano dall’altro. Tutte cose che cambiano e si evolvono nel tempo, costringendo ogni generazione a riformulare coscientemente problemi, priorità, corsi possibili di azione, in un lavoro nel quale scienze sociali, storia, ecologia, agronomia, geografia, economia, devono giocoforza lavorare insieme, come possono.
Chiude il volume una riflessione sul ruolo e il significato dell’agricoltura nell’Italia di inizio millennio, già pubblicata come introduzione al libro del 2018 “Ultime notizie dalla terra”, una raccolta di reportage – ora si chiamano longform – scritti per l’edizione di Napoli del quotidiano “la Repubblica”. Il progetto ideato con Ottavio Ragone, responsabile della redazione napoletana del giornale, era quello di raccontare a un pubblico più largo, mentre infuriava la tempesta di “Terra dei fuochi”, le diverse agricolture della Campania, i processi, i paesaggi, le persone che ci lavorano, evitando i pregiudizi generalizzati che stavano screditando un intero settore della società e dell’economia, oltre che le matrici ambientali, le terre, i suoli, le acque di un’intera regione.
C’entra qui la questione del giornalismo, un’esperienza per me fondamentale di conoscenza e formazione. Il metodo in fondo è sempre quello: documentarsi, andare sui luoghi, osservare, parlare con le persone, e poi velocemente buttar giù un racconto, badando che sia interessante, che venga voglia di leggerlo, che parli una lingua credibile, vicina a quella del lettore. Tutte cose che sei costretto a fare in un tempo limitato, e la cosa che colpisce è la capacità di questi scritti partoriti in velocità, quando li riprendi poi a distanza di tempo, di sorprenderti ancora, di proporti squarci inattesi di ragionamento, farti riscoprire cose che non sapevi di sapere. La conclusione è che si tratta a tutti gli effetti di una ricerca sul campo, e non sbagliava Manlio Rossi-Doria quando diceva ai suoi studenti che lo strumento più importante per un economista agrario è la suola delle scarpe, per sentire camminando come cambia la qualità del suolo. Per quanti avessero interesse, articoli e reportage sono tutti raccolti nel blog che in qualche modo cerco di far vivere, l’indirizzo è http://www.horatiopost.com. Il libro termina con un frammento, l’incipit di un racconto pubblicato nel 2008, con le illustrazioni emozionanti di Oreste Casalini, il titolo di quel librino era “La terra lasciata”, per tanti motivi riprenderlo mi è sembrato un buon modo di chiudere il volume, così come il paesaggio di Oreste in copertina il modo migliore per iniziarlo. In ultimo devo ringraziare Vezio De Lucia, con il quale ho discusso tante volte le cose trattate in queste pagine, per le osservazioni e i consigli che mi ha dato nella realizzazione del libro.

Antonio di Gennaro, la Repubblica, ediz. Napoli, 17 febbraio 2025
Parla delle cose che sono ora al centro del dibattito pubblico il nuovo libro di Carlo Iannello “Lo Stato del potere. Politica e diritto ai tempi della post-libertà”: l’erosione dei poteri democratici ad opera dei nuovi padroni del web e della finanza. Si tratta di cose divenute evidenti a tutti dopo l’elezione del nuovo presidente americano: l’avanzata delle tecno-destre, descritta e analizzata negli articoli di Ezio Mauro su questo giornale, la cui forza propulsiva è “l’innesto del capitalismo tecnologico billionario sul tronco reazionario del trumpismo, generando un nuovo fenomeno culturale e politico che segnerà questa stagione: la tech right come l’ha chiamata Elon Musk.”
E’ un fenomeno del quale si è dovuto occupare il presidente Mattarella nel suo discorso di Marsiglia, indicando tra i nuovi pericoli che la democrazia deve affrontare i “neo-feudatari del Terzo millennio – novelli corsari a cui attribuire patenti – che aspirano a vedersi affidare signorie nella dimensione pubblica, per gestire parti dei beni comuni rappresentati dal cyberspazio nonché dallo spazio extra-atmosferico, quasi usurpatori delle sovranità democratiche.”
Queste cose Carlo Iannello, nella sua veste di costituzionalista, non si limita a descriverle, a prenderne atto: come scrive nella prefazione Giancarlo Montedoro l’autore “scava sul duro terreno dei fatti per cercare di portarne alla luce la logica”, e la forza del libro sta nell’analisi storica, per capire in quali modi, seguendo quali strade, questi processi si sono formati e rafforzati nell’arco dell’ultimo quarantennio, sino agli esiti attuali.
Una ricerca rigorosa, per capire come sono riusciti i nuovi signori delle imprese monopolistiche, delle piattaforme web e dei fondi di investimento globali a restringere via via lo spazio dei poteri elettivi, prendendo come dice Sergio Marotta nella post-fazione, “decisioni elaborate nella sfera privata e che valgono per tutti nella sfera pubblica, perché si configurano come nuove normatività.”
Il problema numero uno studiato da Iannello è l’erosione dei poteri dello stato novecentesco: “la sola organizzazione politica in cui, a partire dal periodo liberale, si è svolto il confronto democratico e in cui si è sviluppato il costituzionalismo, ossia una teoria politica dei limiti al potere che ha stabilito un legame essenziale tra rappresentati e rappresentanti”.
Una mutilazione dei poteri rappresentativi che, nelle parole dell’autore ha “minato la possibilità stessa di realizzare politiche redistributive del reddito da parte dello Stato e indebolito il Welfare State, oramai non più in grado di assolvere i suoi compiti” proprio nel momento storico nel quale è massima “la precarizzazione del mondo del lavoro, lo smantellamento del settore industriale pubblico, il trasferimento della ricchezza collettiva nelle mani dei nuovi attori del mercato” secondo un trend che ha “accresciuto la povertà e concentrato la ricchezza in una misura che non si era mai vista nella storia pregressa del capitalismo industriale.”
Nel raccontare tutte queste cose, la forza del libro di Iannello – dedicato a Gerardo Marotta nell’anno del cinquantenario della fondazione dell’istituto Italiano per gli Studi Filosofici – sta molto nello stile che l’autore ha adottato, che è quello di un reportage fluente, non specialistico, che ti prende e ti conquista, fornendo nel contempo a studiosi e lettori desiderosi di approfondire un apparato bibliografico e critico imponente.
La possibile via d’uscita Iannello la indica nel capitolo finale del libro, programmaticamente titolato “In difesa dell’umano. Invertire l’ordine delle priorità: prima l’uomo poi l’economia”.
Per fare questo è necessario con estrema tenacia difendere le forme liberal-democratiche delle nostre istituzioni, che “permangono, nonostante i fini per la realizzazione dei quali tali forme erano state concepite siano stati sovvertiti.”
Secondo Iannello questa difesa è “il punto da cui riprendere il percorso interrotto, la base su cui iniziare il cammino di ricostruzione”, attraverso azioni quotidiane, individuali e collettive di riaffermazione dei diritti della persona, riprendendo senza paure il programma che la Costituzione del 1948 ha limpidamente segnato.

Tutti insieme, gli articoli pubblicati sull’edizione napoletana di Repubblica dal luglio 2023 ad oggi. Come un diario. Tra le altre cose, i due reportage scritti con Giuseppe Guida dopo la pubblicazione di “Sette pezzi facili”. Se il librino del 2022, scritto durante la pandemia, si muoveva tutto dentro i confini della città, questa volta il viaggio è nella grande area metropolitana, la pianura scombinata, e poi Caivano. Ci sono alcune pagine che è stato più difficile scrivere, il saluto a Pio Russo Krauss che ci ha lasciati lo scorso mese di agosto, una persona importante per molti di noi, per la città, un fratello.
La città diseguale

Antonio di Gennaro, 9 novembre 2024
Ce la farà la città a reggere il boom turistico? I numeri sono importanti: 140mila sono i turisti che, stando alle stime rese pubbliche, hanno scelto Napoli per il ponte di Ognissanti (per inciso, a Firenze sono stati 480.000): è come se in quei giorni la popolazione urbana fosse cresciuta del 15%; come se una città come Rimini avesse deciso, in blocco, di venire a stare un po’ da noi.
I numeri sono importanti, soprattutto per il fatto che il carico non è equamente distribuito, grava in buona parte sul centro storico, già congestionato di suo, mandando in sofferenza i funzionamenti urbani e la gracile rete dei servizi. È evidente, lo ripetono in molti, che la cosa va governata: senza una strategia, come già successo altrove, il turismo, che è solo una parte dell’economia di una città, finisce per consumare e trasformare la risorsa che lo ha generato.
Di gratificante, oltre al fatturato, c’è l’interesse, l’attrattiva, il soft power che la città oggi è in grado di esercitare, e pure è stato evidenziato da molti come questa narrazione positiva rischi di fare da coperta ai problemi, che rimangono crudi e irrisolti al di sotto.
È vero, non dobbiamo aver paura dei cambiamenti, e il successo turistico un effetto sicuramente positivo può averlo, quello di costringerci finalmente a definire una strategia, a tracciare una traiettoria deliberata per la Napoli che immaginiamo. Partendo dall’aspetto che in questo momento, ci piaccia o no, ci definisce di più, che è la disparità di condizioni di vita tra le persone e i territori che tutti insieme compongono la città.
Tra le grandi città italiane non c’è alcun dubbio che Napoli sia quella dove le distanze e le diseguaglianze sono maggiori. L’alleanza che si è formata sul campo tra ciò che rimane della scuola pubblica, il terzo settore e la Chiesa ha aiutato sino ad ora a fronteggiare l’emergenza delle innumerevoli povertà (abitativa, economica, educativa, sanitaria, di servizi e spazi collettivi), supplendo in qualche modo alla gracilità delle politiche e delle strutture pubbliche, ma ora questo non basta più, la guerra dei quindicenni armati è lì a ricordarcelo.
Se non agiamo sulle diseguaglianze, quartiere per quartiere, ogni politica di rilancio economico della città è destinata a fallire. I ragazzi continueranno ad andar via, la città a svuotarsi delle sue energie migliori. I tempi delle grandi trasformazioni che sono state avviate, a cominciare da Bagnoli, sono ancora lunghi e incerti: senza un pensiero che li tenga insieme, senza una maglia di politiche diffuse che interessi l’intero tessuto cittadino, quello che rimane è un parco progetti di grandi opere che, come in passato, non ce la fanno a cambiare la vita delle persone.
Dobbiamo lavorare sulle distanze che ci separano. Lasciando pure a Greta Cool, la diva decadente di Parthenope, nel suo universo onirico, tutta la libertà di disquisire sulle tare insanabili del nostro carattere collettivo: noi abbiamo un altro lavoro da fare, maledettamente più pratico e urgente.
Una vita dalla parte degli ultimi

Antonio di Gennaro, 17 agosto 2024
Ci ha lasciati d’improvviso Pio Russo Krauss, una malattia crudele se l’è portato via in poche settimane. Medico pediatra valente, una vita nella sanità pubblica al servizio dei piccoli, degli ultimi, degli esclusi. Un percorso lungo, su tanti fronti diversi, iniziato da ragazzo nei primi anni ’70, nel movimento cattolico, poi in quello delle comunità cristiane di base. Ma Pio è stato anche pioniere a Napoli della cultura ambientalista e pacifista, animatore cocciuto e instancabile di innumerevoli iniziative e battaglie in campo medico, culturale, sociale.
Per molti di noi è stato il fratello maggiore, e non era questione d’età: c’entra invece la personalità solida, la serietà, il lavoro di preparazione e studio che metteva in tutte le sue cose, senza fanatismi, vagliando con pazienza problemi e situazioni, alla luce della ragione, della fiducia nella persona, della responsabilità indefettibile verso gli ultimi che gli veniva dal Vangelo.
Alimentava tutto il suo amore per la vita, la musica, la letteratura: la passione per il cinema la mia generazione l’ha coltivata al cineforum del Centro Culturale Giovanile che lui ha diretto per un decennio. E poi la passione per la natura, le lunghe, indimenticabili escursioni in montagna, la sua conoscenza della sentieristica era vasta e precisa, con lui non ti perdevi mai.
È riuscito a tenere insieme tanti mondi diversi. Nel suo messaggio di commiato pubblicato in rete il giorno della fine ha scritto: “La vita ha senso se spesa per gli altri, per migliorare la società, per prendersi cura di chi è in difficoltà, per aiutare gli ultimi a sollevarsi.
La vita è bella. Godete delle bellezze della natura, dell’arte, della compagnia di chi vi vuole bene. Il denaro dà la felicità solo a chi ne ha poco, ma molto spesso può rovinare l’esistenza a tutti gli altri. Non affannatevi per esso e siate generosi con chi è povero, molto generosi, ma con intelligenza per aiutarli efficacemente.
Non credete a chi vi offre spiegazioni semplici dei problemi della nostra società (e non solo di essa), a chi propone soluzioni facili, a chi promette troppo: la realtà è complessa e difficile da cambiare, ma cambia e noi possiamo indirizzarla in un verso o in un altro.”
In questo momento di dolore ci stringiamo a Gigliola, la compagna di una vita, alle tre figlie Irene, Chiara e Giovanna che sono state il suo amore e il suo orgoglio. La città gli deve molto, è stata un posto migliore e più umano perché c’era lui, e anche un po’ più giusto. Che la terra ti sia lieve.
Ricostruire Ischia partendo dal paesaggio

Antonio di Gennaro, 9 luglio 2024
Dei tre gioielli del Golfo è Ischia, l’isola verde, per molti aspetti l’ecosistema più fragile, una storia lunga e dolorosa di sismi e dissesti ricorrenti nei secoli, sino a quelli più recenti, il terremoto del 2017, poi le frane del 2022: la vita di tre comuni – Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio – scossa ancora una volta alle radici.
Per la ricostruzione questa volta, vista l’ampiezza dell’area interessata, e la complessità dei problemi da affrontare, c’è voluta una legge dello Stato, con la scelta opportuna di assegnare a un piano unitario la definizione degli interventi sul patrimonio distrutto, lesionato, a rischio, affrontando in maniera integrata e non più settoriale gli aspetti urbanistici, i rischi ambientali, il paesaggio.
Un piano di ricostruzione che ha quindi caratteristiche nuove rispetto alla disciplina precedente, che nasce dal dialogo necessario e dal lavoro comune tra le diverse competenze istituzionali, i livelli di governo, i centri di competenza e il mondo della ricerca.
Uno dei risultati importanti di questa collaborazione è l’accordo siglato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, e l’Assessorato al Governo del Territorio e all’Urbanistica della Regione Campania, sulla nuova disciplina paesaggistica per l’Isola d’Ischia, il nuovo quadro di riferimento cui il piano di ricostruzione è chiamato a conformarsi.
Si tratta di un lavoro fondamentale, tenuto conto del fatto che il territorio dell’isola è interamente sottoposto a tutela: un paesaggio unitario che va dal crinale dell’Epomeo al mare, passando per i boschi, i terrazzamenti agricoli, i pezzi di città storica, sino alle bellezze della fascia costiera, non tralasciando naturalmente gli insediamenti recenti, cresciuti troppo e male in un sessantennio di governo a bassa intensità.
La disciplina messa a punto da Soprintendenza e Regione è precisa e rigorosa, e ha per oggetto, una ad una, tutte le diverse componenti di questo mosaico paesaggistico complesso, dettagliatamente cartografate, con la definizione chiara degli usi non ammissibili e di quelli ammissibili a condizione, con l’obiettivo di garantire la tutela e la conservazione di ciascun bene – boschi, terrazzamenti, città storica, fascia costiera – ma anche di definire le modalità concrete per la loro gestione attiva, cura, manutenzione, messa in sicurezza.
Gli obiettivi sono maledettamente concreti: rigenerare pienamente la capacità protettiva dei boschi sofferenti dell’Epomeo, dopo un sessantennio di abbandono; curare e ripristinare i terrazzamenti agricoli tradizionali che sono la vera matrice della civiltà millenaria dell’Isola; conservare forma e identità della città storica; rispettare gelosamente il suolo fertile che rimane, e poi quel bene primario per l’economia dell’Isola che è lo straordinario sistema costiero, considerato nel suo insieme.
E’ il metodo che si sta impiegando per redigere l’intero Piano paesaggistico regionale, del quale il protocollo sottoscritto per Ischia costituisce in qualche modo un’anticipazione, con l’obiettivo di fornire da subito al Piano di ricostruzione, tenuto conto dell’impellenza di legge, un riferimento normativo che ne garantisca piena efficacia e coerenza, un percorso e tempi celeri di attuazione.
In una storia dolorosa, la notizia buona è il fatto che le istituzioni stiano lavorando insieme, impiegando per una volta le rispettive competenze come strumenti di soluzione, piuttosto che come elementi di contesa. La ricostruzione questa volta parte dal paesaggio, dalla consapevolezza della nostra storia, della ricchezza e fragilità della terra che abitiamo, non è cosa da poco.
La collina e noi

Antonio di Gennaro, 21 giugno 2024
Giovedì mattina ore sei. Dallo svincolo rampante del Vomero la collina non si vede più, c’è una luce buia d’afa nuvole e fumo che copre questo pezzo di città, dietro la cortina il sole è un disco pallido. Continuando sulla perimetrale di Soccavo l’odore è acre, la pioggia di cenere ha coperto tutto, colonne di fumo s’alzano dalle praterie carbonizzate, ma lingue vivide di fuoco guizzano ancora in alto tra i lecci e gli olmi, nei lembi di bosco dei valloni che scendono dai Camaldolilli. E’ l’alba della prima notte tropicale dell’anno, il termometro segna già 25 gradi, chi ha agito lo ha fatto con cognizione
L’incendio è stato appiccato nella giornata di mercoledì, bisognerà capire bene quando, i punti d’innesco, localizzati ad arte, sono stati individuati. Le operazioni di spegnimento con le squadre a terra e i mezzi aerei, sono iniziate con qualche difficoltà, continuate fino a che c’è stata luce, poi col buio gli aerei si sono dovuti posare, una norma nazionale non ne consente l’impiego notturno, gli uomini a terra sono rimasti a presidio delle abitazioni, l’incendio però ha potuto estendersi per l’intero versante, e sembrava domato infine con la ripresa dei voli nella mattinata di giovedì, anche se gli elicotteri hanno ancora dovuto levarsi nel pomeriggio di ieri per focolai ancora attivi sul versante di Pianura.
Il bilancio ad oggi è che il mosaico di ecosistemi verdi sul versante collinare che guarda Soccavo, un ricamo di praterie, macchie, garighe, boschi misti s’è bruciato su quasi ottanta ettari, a fuoco anche alcuni vigneti di pregio, è come se il Parco di Capodimonte fosse andato in fumo per due terzi.
Stiamo parlando di pezzi di paesaggio importanti della città, sul versante bruciato riemerge a tratti la trama dei ciglionamenti medioevali che è ancora presente, nascosta dalla prateria, dopo che negli anni sessanta l’agricoltura eroica ha abbandonato queste terre cariche di storia. Intanto, negli impluvi spogliati della vegetazione, l’acqua lanciata per lo spegnimento ha già solcato il suolo fragile, un lavoro erosivo che le piogge nel tempo completeranno.
Sono pezzi maltrattati della collina che continua a vivere seppur incastrata nella città, una miniera sorprendente di biodiversità, suolo ancora vivo che nonostante l’incuria continua a lavorare per noi, in silenzio, producendo i servizi ecologici necessari alla città per funzionare: mitigazione del microclima urbano, assorbimento della CO2 e del particolato, infiltrazione dell’acqua, produzione agricola di prossimità, habitat di vita di una comunità sorprendente di organismi. Tutti servizi che, oltre al mantenimento della vita, partecipano di fatto con un loro preciso valore monetario all’economia della città, anche se ci ostiniamo a non capirlo.
Di fronte a eventi come quello di mercoledì la città deve decidere che farsene di questo capitale naturale. L’incendio questa macchina verde l’ha colpita, azzerata, ridotta a una landa fumante su una superficie pari a 112 campi di calcio. Prima di pensare alla moda della nuova forestazione urbana, bisognerebbe impegnarsi per curare la natura che abbiamo già, e a metterla in sicurezza, prima che vada a fuoco o ci frani addosso.
Le parole chiave sono prevenzione e rapidità d’intervento. I rischi si combattono vent’anni prima. Gli ecosistemi verdi in città devono essere curati, tenuti in ordine, monitorati. Bisogna investire attivamente su di essi, prima che le cose succedano. E quando accadono, essere pronti ad agire con tempestività: nella lotta attiva agli incendi, quelli di interfaccia col sistema urbano innanzitutto, il fattore tempo è tutto, se il fuoco prende piede la dinamica diventa incontrollabile. Tutte cose che devono entrare a far parte della programmazione e gestione ordinaria, nel tempo mutato nel quale ci troviamo a vivere concetti, come “eccezionale” o “emergenza” devono essere espulsi definitivamente dalla prassi e dal vocabolario.
Il villaggio della sicurezza a Bagnoli, subito
Antonio di Gennaro, 22 maggio 2024

Nella sequenza infinita degli annunci, c’è una cosa concreta da fare subito a Bagnoli, in risposta a questo momento difficile per la città e l’intera area flegrea, ed è un villaggio provvisorio per la sicurezza.
Nel racconto che hanno fatto i media di tutto il mondo, l’aspetto più penoso è il senso di precarietà, le immagini dei molti concittadini di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e non solo, che hanno trascorso la notte all’aperto, o accampati in macchina, nel parcheggio dormitorio improvvisato fuori l’ex base Nato.
Evitando di incoraggiare allarmismi inutili, è evidente come nella fase di incertezza che stiamo vivendo, sia comunque utile e doveroso prevedere ricoveri provvisori per le persone e le famiglie che nei momenti di maggiore attività sismica non si sentano sicuri all’interno delle mura domestiche.
Ieri su queste pagine l’antropologo Giovanni Gugg ha spiegato con chiarezza come sia difficile e importante ricostruire nella lunga durata un rapporto consapevole con queste terre che si muovono, che pure abitiamo da millenni. E’ una lezione che non è acquisita per sempre: l’esperienza vissuta negli anni ’70 e ‘80, per molti versi ben più difficile e drammatica di questa, purtroppo non ci viene in soccorso, le fasce giovani non l’hanno conosciuta, ed allora dobbiamo ripartire da zero.
Gli esperti ci dicono che lo sciame sismico, che tanto scuote la nostra psiche, contiene invece un aspetto di sicurezza, è un’energia che il sistema dinamico libera gradatamente, evitando accumuli di tensione pericolosi, in una successione di eventi la cui magnitudo è ritenuta sopportabile dal patrimonio edilizio che abitiamo.
Ma tutto questo alle persone non basta, e la domanda generale è quella di informazioni puntuali e adeguate sulla vulnerabilità, non della città nel suo complesso, ma del condominio, dell’appartamento nel quale ciascuno di noi vive.
Nel frattempo che questo accada, città importanti come Napoli e Pozzuoli devono poter disporre di spazi provvisori di accoglienza e ospitalità per i momenti più acuti, e Napoli questo spazio ce l’ha, nella fascia di quindici ettari che costeggia via Diocleziano, passato il ponte ferroviario e l’auditorium. E’ spazio aperto, sicuro, vicino alla città, nel cuore di uno dei quartieri che più sta soffrendo la crisi, ben servito dalla rete stradale e del ferro.
Si tratterebbe di un uso provvisorio, certo, e sarebbe anche finalmente il modo di far rientrare pienamente queste aree sequestrate da un trentennio di bonifica inutile, costosa, senza fine, nel circuito urbano, nella vita pulsante della città, ora che veramente ne abbiamo bisogno.
Dietro le quinte a Caivano

Antonio di Gennaro e Giuseppe Guida, 2 giugno 2024
C’è un blocco in autostrada, e allora dopo l’aeroporto prendiamo la vecchia statale sannitica che divide San Pietro a Patierno da Secondigliano, ora è diventata il corso della sterminata città senza nome che si è formata da sola dopo il terremoto dell’80, della quale la statale attraversa ad uno ad uno i quartieri: Casavatore, Casoria, Afragola, Cardito. Dopo nove chilometri e pochi minuti è il turno di Caivano, corso Umberto I è una bella strada di centro storico, con le masserie e le dimore padronali restaurate. Giriamo per via de Nicola, ancora poco, a ovest, il Parco Verde è l’ultimo avamposto della metropoli napoletana, sulle sponde del fiume residuo di campi agricoli che la separa, non si ancora per quanto, dall’altro pezzo di conurbazione, quella aversana.
All’ingresso del “parco” troviamo ad aspettarci Bruno Mazza, in bicicletta, assieme a Sobir, un ragazzino di colore di dodici anni tutt’occhi, sveglio e silenzioso. La famiglia di Bruno è venuta qui nell’86 dai container della Sanità, per lui una giovinezza sbagliata, il carcere, poi il cambiamento di vita, la decisione nel 2008 di fondare un’associazione, “Un’infanzia da vivere”, per aiutare i piccoli come Sobir a non subire lo stesso destino.
Il giorno prima si è tenuto qui lo show governativo, quello delle parolacce, ma dietro le quinte, spente luci e telecamere, nessuna traccia è rimasta, con Bruno e Sobir percorriamo il quartiere viale per viale, tra i prefabbricati pesanti lo stato di abbandono è totale, le aiuole sono muri di erbacce altissime e rifiuti, le botteghe chiuse, in rovina, una signora dalla macchina ci chiede gridando quando vengono a ripristinare l’illuminazione nel suo viale, sono al buio da quindici giorni.
“Quello che il quartiere continua inutilmente a chiedere” ci dice Bruno “è semplicemente un minimo di cura, di manutenzione, presidio, attenzione quotidiana, pulizia, spazi decenti e sicuri da vivere e abitare”. Ed è proprio quello che nel suo piccolo l’associazione cerca di fare da quasi vent’anni.
Arriviamo ai campetti di calcio che un “Infanzia da vivere” ha realizzato e gestisce in Via Rosa – qui i nomi dei viali sono esclusivamente floreali – con un finanziamento della Fondazione Con il Sud, che fin dall’inizio ha creduto in questa storia. All’ombra di un grande pioppo c’è un casotto aggraziato, un orto, i campi e le attrezzature sono perfetti, arriva un gruppo di ragazzini col pallone, salutano Bruno, si vede che c’è educazione e rispetto per i luoghi e le persone.
Un’altra oasi come questa è a trecento metri da qui, in via Tulipano, un parco giochi per i piccoli da 0 a 6 anni, si chiama “Ohana”, una parola hawaiana che significa “famiglia”, sempre realizzata con l’aiuto della Fondazione Con il Sud, cento bambini vengono a giocarci ogni giorno.
Percorriamo viale delle Magnolie sino alla chiesa di San Paolo Apostolo, davanti la parrocchia l’associazione di Bruno ha adottato un’aiuola triangolare, un’altra piccola oasi in mezzo allo squallore, è dedicata alla lotta sulle violenza sulle donne, c’è una panchina rossa, la sagoma grande di una scarpetta rossa sul prato verde ben tosato.
Addossata alla parrocchia c’è Villa Andersen, un’area verde attrezzata per l’infanzia grande quasi un ettaro, era prevista nel progetto urbanistico che ha generato Parco Verde, ora è in stato di sfascio totale. Con Bruno e Sabir ci inoltriamo cauti nella vegetazione fitta che ha divelto pavimenti, tombini, impianti, distrutto scivoli e giostrine, in rovina anche il campo di calcio.
Trent’anni fa l’accesso dal lato della parrocchia fu chiuso, ci pensarono i capi-famiglia della droga a riaprire l’area facendo breccia nel muro di cinta sull’altro lato del giardino, da allora questo è stato il luogo del consumo e delle morti per overdose. Dal balcone di uno dei prefabbricati affacciato sulla villa una donna quando ci vede inizia a gridare, dalla vegetazione incolta le entra in casa ogni genere di volatile, chiede quando faranno finalmente pulizia.
“La rinascita di Caivano doveva partire da qui” ci dice Bruno “gli abitanti e le associazioni del quartiere lo avevano chiesto con forza al governo, dei 1300 bambini del rione 500 vivono intorno a Villa Andersen, a contatto quotidiano diretto con questa bruttezza”. Restituire finalmente la villa a condizioni quotidiane di legalità sicurezza e decoro sarebbe davvero per tutto il quartiere il segno autentico della svolta.
Eppure inspiegabilmente quest’area che è il vero epicentro dell’illegalità e del dolore, non è entrata negli ultimi programmi governativi, sintetizzati nel cosiddetto Decreto Caivano. L’intervento più reclamizzato è invece quello che riguarda il centro sportivo comunale e la piscina oggi denominata “Pino Daniele”, a mezzo chilometro da qui, oltre la strada perimetrale a scorrimento veloce, ben distante dal quartiere e dalla vita di ogni giorno. Per gli abitanti del rione certamente non la priorità.
Alla fine quello che si percepisce è il carattere, neppure tanto celato, dell’intervento governativo per Caivano: l’idea di una politica esemplare e simbolica, più che risolutiva dei problemi; paternalistica (sappiamo noi cos’è meglio per te, tu plaudi e ringrazia); emergenziale, con i commissari e i poteri straordinari che vengono e vanno senza incidere sul contesto: al comune di Caivano nell’ultimo ventennio i commissari straordinari sono stati 8, l’ordinarietà è stata la vera eccezione.
Il risultato è la totale mancanza di ascolto, e l’esclusione dal programma governativo di ogni tipo di contributo, ideale, organizzativo, gestionale, da parte della rete di associazioni del quartiere, che pure una visione e una capacità operativa in tutti questi anni hanno dimostrato di possedere.
Nei locali in viale Margherita dove ha sede l’associazione con Bruno proviamo a buttar giù una mappa orientativa della rete sociale attiva a Caivano. Accanto a “Infanzia da vivere”, in un rapporto di stretta collaborazione, c’è la cooperativa sociale “Nessuno resti solo”, nata per iniziativa di Cristina Giordano e di trenta giovani mamme del quartiere. Un ruolo decisivo, come si è detto, lo ha avuto la Fondazione Con il Sud con il presidente Stefano Consiglio; un sostegno importante è venuto da “Impresa Sociale” diretta da Marco Rossi Doria. Dalla collaborazione con il “Centro di servizio per il volontariato di Napoli” (CSV) è nato un corso per la formazione di 10 volontari civili da impiegare nei programmi per il quartiere; quella con il “Banco Alimentare Campania” consente gli aiuti settimanali alle famiglie in difficoltà. Tra le aziende private che hanno sostenuto il processo c’è la Farvima spa, importante realtà nel campo farmaceutico.
Se la priorità è la qualità e la sicurezza degli spazi di vita quotidiana nel quartiere il passo successivo per le istituzioni, una volta superata l’ottica emergenziale che nulla ha prodotto, sarà mettere mano a questa sorta di terra di mezzo nella quale realtà come il Parco verde si trovano disperse, riannodando i fili di un territorio smembrato, ma straordinariamente ricco di risorse.
«Quando nei primi mesi del 1982 ci recammo sull’area del progetto per il primo sopralluogo ci trovammo di fronte ad una sterminata piana agricola, inframmezzata da lunghi filari di vite maritata al pioppo», così ci racconta Francesco Bruno, allora docente di Progettazione Architettonica alla Facoltà di Architettura di Napoli e autore del progetto planivolumetrico dell’intero insediamento, ben disegnato da un punto di vista tecnico e allineato ai migliori canoni del tardo modernismo allora in voga e dimensionato per circa 750 alloggi. Gli edifici del Parco Verde furono progettati dall’architetto aversano Arturo Pozzi, per la realizzazione fu utilizzato un sistema di prefabbricazione pesante, stile città sovietica anni ’70, con prestazioni energetiche e termiche pari a zero.
Ancora oggi, se alzi lo sguardo, ti accorgi di come la radice rurale dell’antico casale sia ancora viva, il Parco Verde si affaccia su un’area agricola immensa, oltre duemila ettari che sono parte della grande pianura dei Regi Lagni. Qui si produce ancora un quarto della produzione nazionale di patate, e sono le più pregiate e richieste, al di là delle cose infondate che su questa agricoltura sono state dette.
Oltre i campi, superato il borgo antico di Pascarola, c’è un’area industriale tra le più importanti del Mezzogiorno e d’Italia. Ora è una sorta di repubblica autonoma, al check point quando chiediamo di entrare ci guardano con sospetto, all’interno tutto è ordine, con le grandi strade alberate, il caos e le sofferenze restano fuori del recinto.
Un chilometro più avanti, superata l’Alta velocità, l’altro grande polo industriale, orafo, della Coca Cola, dove la Olivetti negli anni ’70 impiantò su progetto di Marco Zanuso ed Eduardo Vittoria uno stabilimento avanzatissimo per la produzione di macchine computazionali, dando ancora vita alla visione del suo fondatore, di una piena integrazione tra urbs, civitas e produzione industriale.
È di una visione come questa che abbiamo ancora bisogno. La cosa da fare è trasformare senza indugio questa terra di mezzo in un grande parco agricolo e produttivo, riattivando le antiche strade interpoderali, lungo i tracciati della centuratio, rigenerando all’originaria funzione la canalizzazione storica dei Regi Lagni che innerva l’intera area, riaprendo i varchi che separano le aree produttive dal territorio intorno.
Superando anche le barriere mentali, che sono le più dure di tutte, perché Parco Verde non è una monade nel nulla. La distanza tra il quartiere e la stazione dell’alta velocità di Afragola è la stessa che intercorre tra la stazione Centrale di Napoli e il quartiere di Chiaia. Così come la distanza tra Caivano e Napoli è la medesima che passa tra l’Eur e i Parioli a Roma. Parco Verde è un pezzo di Napoli, popolato all’80% da cittadini che in origine risiedevano a Napoli, che però sentono di essere altrove, in una terra priva di riferimenti e coordinate, ma non è così.
Mentre percorri questo mondo complicato, ti chiedi come sia possibile, con queste risorse economiche e paesaggistiche, che a prevalere sia stata l’economia criminale e non quella industriale e agricola che sta proprio di fonte al Parco Verde; perché non si intravedano all’orizzonte grandi programmi di rigenerazione del territorio che mettano allo stesso tavolo tutti gli attori che popolano quest’area, con le proprie responsabilità, per ricomporre i pezzi della conurbazione, sostenere forme di sviluppo innovative, condivise, coraggiose; dare finalmente risposta alle urgenze dolorose di vita quotidiana e di futuro possibile che Bruno e Sabir ci hanno con semplicità mostrato e fatto conoscere.
L’azzardo Bagnoli

Antonio di Gennaro, 2 aprile 2024
L’articolo di Pasquale Tina pubblicato su queste pagine il giorno di Pasqua (“Napoli, la guerra dello stadio”) mette ordinatamente in fila tutte le cose che sappiamo intorno alla questione del nuovo stadio. Rispetto alle notizie dei giorni precedenti la novità riguarda l’avvenuto incontro del presidente e proprietario del Calcio Napoli Aurelio De Laurentis con Bernardo Mattarella, presidente di Invitalia, la società pubblica alla quale la legge “Sblocca Italia” del 2014 ha assegnato la proprietà dei suoli dell’area ex Ilva di Bagnoli.
Dall’incontro sarebbe scaturito un via libero preventivo di Invitalia alla proposta di De Laurentiis di realizzare proprio a Bagnoli il nuovo stadio da 60mila spettatori, come parte di un più ampio complesso sportivo e ricettivo, con l’indicazione di una possibile data di inaugurazione della struttura, nel luglio 2027.
Di segno opposto l’opinione del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che è anche commissario straordinario di governo per il risanamento di Bagnoli, secondo il quale l’opzione realistica consiste nell’adeguamento dello stadio Maradona, essendo la proposta del nuovo stadio a Bagnoli non praticabile, a causa della tempistica (il completamento della bonifica richiederà un periodo di tempo non inferiore ai 3-5 anni), e per il fatto che la proprietà dei suoli è di Invitalia, con la necessità quindi di un acquisto preventivo delle aree da parte di De Laurentiis.
Sul restyling del Maradona il sindaco ha ragione da vendere. Sta di fatto che Invitalia nella vicenda di Bagnoli non è un soggetto qualsiasi, assommando i ruoli di soggetto attuatore della bonifica, oltre che di proprietaria dei suoli. L’apertura a De Laurentiis, se confermata, starebbe a indicare che i vertici di Invitalia ritengono le obiezioni del sindaco Manfredi in qualche modo superabili.
Ciò che colpisce in tutta questa vicenda è il completo prevalere delle questioni procedurali su quelle di merito. La disciplina urbanistica, che la Costituzione e le leggi italiane assegnano ancora agli enti di governo territoriale, in primis i comuni, e non ai proprietari delle aree (sia chiaro, Invitalia, per quanto società di intera proprietà pubblica, è un soggetto di diritto privato come gli altri), nonché il quadro complessivo dei vincoli, non consentono assolutamente la localizzazione a Bagnoli di un’attrezzatura del rango del nuovo stadio, e ha ragione allora Giuseppe Guida, nel suo intervento su queste pagine dell’11 marzo scorso, a derubricare la questione nell’ambito della patafisica.
Anche volendo prescindere da tutto questo, c’è una questione di buon senso grande quanto una casa, che dovrebbe sconsigliare la localizzazione di un nuovo stadio da 60.000 posti nel bel mezzo della zona rossa dei Campi Flegrei, istituita nel giugno 2016 dalla pianificazione nazionale di emergenza per il rischio vulcanico, che comprende l’intera piana di Bagnoli, assieme al promontorio di Posillipo.
Un’area nella quale, stando al sito del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile “… l’evacuazione preventiva è, in caso di allarme, l’unica misura di salvaguardia per la popolazione. In caso di eruzione, sarebbe infatti esposta al pericolo di invasione di flussi piroclastici che, per le loro elevate temperature e velocità, rappresentano il fenomeno più pericoloso per le persone.”
Il dibattito scientifico e istituzionale sull’evoluzione recente del rischio vulcanico e bradisismico nell’area flegrea, le preoccupazioni per l’incompletezza delle nostre conoscenze e capacità previsionali, oltre alla presa d’atto dell’insufficienza delle vie di fuga (a proposito, come si evacuano 60.000 persone dal cul de sac di Bagnoli?), hanno occupato fino a ieri pagine intere dei quotidiani. Come sia possibile rimuovere completamente la questione dal dibattito in corso sul nuovo stadio rimane uno dei misteri della mente umana.
Le vicende storiche che stiamo vivendo dovrebbero indurci invece a immaginare una strada nuova, sobria intelligente per Bagnoli e la zona occidentale, che metta insieme, a partire dai bisogni delle persone, le ragioni dell’economia e del paesaggio, con l’obiettivo di costruire una città più sicura e resiliente. Il nuovo piano urbanistico della città dovrebbe farsi carico di tutto questo, sempre ricordando che Napoli è un segmento di un sistema vulcanico ed ambientale più ampio, maledettamente problematico, ed è a questa scala vasta che le soluzioni ragionevoli vanno ricercate.
C’è un altro modo di dividere il paese

Antonio di Gennaro, 21 marzo 2024
Andiamo sempre più scoprendo in questi ultimi mesi che esiste un diverso modo di mandare in frantumi l’unità del paese, oltre all’autonomia differenziata di Calderoli, ed è l’approccio con il quale l’attuale governo sta trattando partite importanti, a partire da quelle che riguardano l’uso delle risorse finanziarie.
Le recenti modifiche apportate unilateralmente, senza spiegazioni, al Piano nazionale di recupero e resilienza, comporteranno il ridimensionamento di linee di investimento rilevanti, dalla rigenerazione urbana, agli asili, al dissesto idrogeologico. A farne spese saranno soprattutto le città del centro-sud.
Sui tagli alla sanità la levata di scudi è generale, coinvolgendo tutte le regioni, anche quelle governate dal centro-destra, costringendo la Corte dei conti a una denuncia chiara dell’abuso di potere nei confronti dei poteri locali.
Con la Campania la partita è se possibile ancora più aspra, con il mancato accordo sull’impiego delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione, dal quale dipendono grandemente le politiche di sviluppo.
In merito all’aspro contenzioso in corso, le dichiarazioni del ministro Fitto a margine di un recente convegno organizzato dalla CGIL sono rivelatrici delle motivazioni alla base dell’atteggiamento governativo: “Il Governo non ha alcun obbligo previsto in nessuna legge di dare le risorse alle 20 Regioni italiane. È una scelta del Governo dare risorse alle Regioni italiane” ha dichiarato il ministro.
Inutile dire che una simile affermazione cozza contro una manciata di articoli della carta costituzionale: le risorse di cui parla il ministro non sono patrimonio del governo ma della repubblica, che è composta, oltre che dallo stato, dalle regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, che cooperano secondo il principio di sussidiarietà, cioè partendo dai livelli amministrativi più prossimi alla vita dei cittadini.
Le Relazioni sui Conti Pubblici Territoriali pubblicate dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, l’ultima è relativa al 2021, hanno confermato lo squilibrio nella distribuzione delle risorse tra le diverse aree del paese: nell’ultimo ventennio il Mezzogiorno, con il 35 per cento di popolazione, ha percepito mediamente il 27 per cento della spesa pubblica ordinaria. L’obiettivo fissato per legge nel 2017, di riservare al Sud almeno il 34% delle risorse, è stato vistosamente mancato.
Alla fine, stando sempre alle Relazioni dell’Agenzia per la Coesione, nel ventennio considerato sono mancate al Sud risorse per un importo stimabile intorno ai 2,6 miliardi l’anno. A riequilibrare in parte le cose sono intervenute le risorse integrative, in primis i fondi europei, e i fondi di programmazione nazionali, come l’FSC, che non costituiscono più a questo punto risorse aggiuntive, erogate al Mezzogiorno per recuperare il ritardo di sviluppo, ma risorse sostitutive di una quota della spesa pubblica ordinaria che manca.
Stando così le cose, l’erogazione di risorse come quelle del Fondo di sviluppo e coesione non può dipendere da scelte unilaterali e discrezionali del governo, ma da una seria e leale cooperazione istituzionale, nel rispetto degli obiettivi di coesione che la costituzione e le leggi ordinarie ancora impongono. A soffrirne le conseguenze, qualora ciò non avvenisse, sarebbero solo le persone, oltre a ciò che rimane del senso di giustizia e di unità del paese.
Se dieci anni vi sembran pochi

Antonio di Gennaro, 3 febbraio 2024
Il prossimo 12 di settembre, appuntiamoci la data, è una ricorrenza importante, si celebra il decennale del decreto Sblocca-Italia, il provvedimento che doveva mettere fine alle lungaggini e inefficienze che hanno segnato la storia complicata del recupero alla città, dopo un secolo di siderurgia, della piana e del litorale Bagnoli.
Dieci anni sono tanti, siamo passati dal breve al medio termine, basterebbe questo per esprimere una valutazione di efficacia: la verità, dopo un decennio, è che siamo ancora ai preliminari, per il completamento degli interventi di bonifica, le opere di urbanizzazione primaria e gli espropri del waterfront occorreranno 1200 milioni di euro, i fondi per la bonifica a terra ci sarebbero, mentre mancano all’appello 650 milioni per i fondali e la colmata.
Quella della bonifica dei fondali è veramente una storia curiosa. Studi autorevoli della Federico II hanno accertato come lo stato di salute dei fondali del litorale industriale di Bagnoli non sia dissimile da quello del litorale industriale di San Giovanni a est, e da quello del litorale industriale di Pozzuoli a ovest. E’ l’effetto di cent’anni di un sistema industriale costiero diffuso sull’ecosistema marino delle due baie sulle quali si affaccia la città. Sono situazioni che in altri stati con trascorsi simili si affrontano con pragmatismo, lavorando seriamente sul monitoraggio, l’adattamento, la valutazione rigorosa delle condizioni effettive di rischio.
Da noi, quello che si sta preparando invece, è il provvedimento esemplare, un po’ sullo stile di Caivano: interventi localizzati e massicci, non replicabili per costo e intensità a situazioni simili, prossime, che pure ne avrebbero bisogno, perché l’obiettivo è soprattutto simbolico: rappresentare, una capacità d’azione risolutiva, una volta per tutte, dei poteri pubblici, con un carico d’enfasi e prosopopea alla lunga difficilmente digeribile.
Un intervento comunque irragionevole e controverso, tenuto conto dell’impatto devastante sull’ecosistema marino del dragaggio dei fondali, e dei problemi non risolvibili legati al destino delle enormi quantità di fanghi che l’insensata e costosissima operazione produrrà.
Al di là delle valutazioni di efficacia, restano intatti, a distanza di dieci anni dall’approvazione del decreto Sblocca Italia, i motivi fortissimi di perplessità sulla sua impostazione, e sulle procedure stabilite per il recupero dell’area siderurgica di Bagnoli.
Inutile girarci intorno: in un momento nel quale la città, come Costituzione prevede, sta definendo la sua nuova strategia, Bagnoli di fatto resta fuori, in una sorta di extraterritorialità, il suo destino essendo legato alle decisioni di una cabina di regia nella quale, da dieci anni, il Comune siede, privo di prerogative particolari, assieme allo Stato e agli altri enti territoriali, con un ruolo guida energicamente esercitato dal soggetto attuatore, Invitalia, che è anche proprietaria dei suoli.
Si tratta di una situazione veramente al limite: Invitalia è una società per azioni: per quanto interamente di proprietà dello Stato, è a tutti gli effetti un soggetto di diritto privato, al quale il decreto Sblocca Italia ha affidato come si è detto non solo la proprietà dei suoli, ma anche una preminenza di potere nel deciderne la disciplina. Si tratta di distorsioni alle quali altre legislazioni emergenziali ci avevano pure abituato, ma mai sino a tal punto.
Il risultato di questa situazione è il congelamento della visione futura di Bagnoli all’interno di uno schema urbanistico, quello del Piano di rigenerazione urbana partorito dalla cabina di regia, la cui attuabilità e rispondenza agli attuali bisogni della città restano francamente tutte da verificare.
Il tutto comunque condizionato ai risultati di un nuovo onerosissimo progetto di bonifica, che solo ora si accinge a partire, con cronoprogrammi ai quali l’esperienza non consente di dare molto credito, e che risponde ancora a burocratiche logiche tabellari, anziché a fondate e sobrie analisi di rischio, come si fa nelle altre parti del mondo.
Di fronte a questi ragionamenti il mantra di Invitalia è che “non è possibile fermare un treno in corsa”, ma è un’argomentazione che, alla vigilia del mesto decennale dello Sblocca Italia, risulta francamente logora.
Sforzandoci di guardare avanti, le riflessioni problematiche svolte dal sindaco Manfredi in Consiglio comunale, e nel recente incontro in Municipalità a Bagnoli, sulla fattibilità della rimozione della colmata, sono un segnale positivo, se indicatrici della volontà dell’amministrazione comunale, dopo un decennio, di riequilibrare opportunamente i pesi all’interno del processo decisionale per Bagnoli, proponendo un percorso realistico e credibile, ben integrato nella nuova visione di città “giusta, sostenibile e attrattiva” che il piano urbanistico si è impegnato a definire.
Dove finisce la pianura

Antonio di Gennaro e Giuseppe Guida, 18 dicembre 2023
La terra nera dov’erano le fragole e le piante alte di noce ora è un tracciato largo, polveroso, lo percorriamo per centinaia di metri, ai lati è una teoria ininterrotta di cantieri, le reti di metallo e plastica rossa segnano il dedalo dei lotti, il lavoro di uomini e macchine è febbrile, c’è di tutto, villette, case plurifamiliari, palazzine, in un trionfo spontaneo di stili, gusti, velleità, in questa città-strada che sta nascendo in fretta alla periferia di Parete, ai confini del nulla. Come mezzo secolo fa nelle periferie di Napoli, ora è qui, nei comuni della seconda corona tra il capoluogo e Caserta, che la fame di case chiede anarchicamente risposta, e la scena è la stessa.
In un posto dove già attrezzature, spazi pubblici e urbanizzazione primaria scarseggiano, questa nuova scacchiera di case sperdute nelle terre significa, nel giro di pochi mesi, qualche migliaio di abitanti in più: per un comune che ne conta 12.000, una cosa epocale. La domanda è chi pagherà poi, a cose fatte, il debito di standard e servizi essenziali, che è il parametro che trascina ancora questi luoghi al fondo della classifica di qualità della vita.
Come ci fosse una regia, questi momenti di trasformazione convulsa seguono un loro turno. Dopo l’esplosione di Giugliano, nel corso dell’ultimo ventennio è successo in centri come Trentola Ducenta, Orta di Atella, un comune per volta, dove si crea la combinazione giusta di fattori perché la reazione si scateni. Questi cicli locali rapidamente si compiono, la forma urbis va in frantumi, poi l’epicentro si sposta, il gioco a perdere dell’edilizia a debito passa di mano, mentre le carte comunque stanno a posto, anche grazie alle deroghe del “piano casa” che Berlusconi ha piazzato una quindicina di anni fa al centro della scena.
Sono cose che succedono nel cuore di Campania felix, le terre nere nate sulle ceneri flegree di quindicimila anni fa, i suoli agricoli più fertili della galassia. Il valore delle produzioni agricole è il più alto in Italia, Langhe e Chianti esclusi. Proprio a Parete, c’è la più importante produzione di fragole a scala nazionale, di una qualità eccelsa, la grande distribuzione europea fa a botte per assicurarsela. È un’industria verde che crea lavoro, reddito, esportazione, competenza, coesione sociale: una delle poche poste attive di un territorio in sofferenza.
E non è la sola. Non lontano da qui, incontriamo Francesco D’Amore, nella sua bella azienda in località Santa Maria, a Frignano. Francesco è un agronomo visionario, in collaborazione con il Mulino Caputo, una delle più antiche aziende che produce farine a Napoli, si è messo in testa di ricostruire, proprio qui, il paesaggio cerealicolo come lo vide Goethe, arrivando a Napoli da Roma, un pomeriggio di fine ‘700, coi campi di frumento a perdita d’occhio, nel disegno dei filari alti di vita maritata.
L’intuizione è importante, la guerra Russia-Ucraina ci ha fatto comprendere l’importanza strategica dei cereali, del grano, la necessità di diminuire la nostra dipendenza dalle importazioni di quest’oro bianco che è alla base della nostra gastronomia, storia, identità culturale. Così, sulle terre nere, Francesco sperimenta le varietà di frumento e grano duro adatte ai nuovi andamenti climatici, l’innovazione assoluta sono le varietà a semina primaverile, una vera rivoluzione. Tutte queste cose sono diventate un progetto di filiera innovativo, grazie a un finanziamento del ministero dell’agricoltura interesserà tremila ettari qui, in Campania e in altre regioni del Mezzogiorno.
Poi, nel centro storico di Frignano, la sede storica delle Cantine Magliulo è una sosta obbligata della memoria. L’asprinio che beviamo è di un’eleganza assoluta, perché come ha scritto Mario Soldati “non c’è bianco al mondo così assolutamente secco come l’Asprinio, nessuno…”. Raffaele Magliulo ci conduce giù, nella grotta scavata nel tufo grigio, sotto la dimora ottocentesca, dove il vino si affina, poi al podere dove si conservano i filari ad alberata, e l’emozione si ripete: dai ceppi secolari di vite, franchi di piede, si diramano a raggiera i tralci che si elevano fino a quindici metri, sul colonnato solenne dei pioppi. Sono monumenti verdi che raccontano 2.500 anni di storia, furono gli Etruschi a pensarli, ce n’erano 18.000 ettari ancora all’inizio degli anni ’70, oggi ne restano un paio di centinaia, grazie all’opera di custodi appassionati come Raffaele.
Nel viaggio ci accompagnano Gena Iodice e Tommaso Maglione, due interpreti importanti della nostra cultura gastronomica, sposati nella vita, lei è una chef apprezzatissima, che fa vivere la tradizione e la rinnova con intelligenza; Tommaso è un agronomo di esperienza e visione, ha organizzato nella piana una rete di aziende agricole, che lui segue, promuove, consiglia, per produzioni di alta qualità, che poi Gena elabora nelle sue ricette, alla “Tenuta Maglione”, nell’emozionante borgo settecentesco dei mulini, a Triflisco; e all’osteria storica “La Marchesella”, a Giugliano. E’ qui che ascoltiamo il racconto del loro lavoro, rapiti dal menù di Gena, il suo ripieno con scarole crude, capperi olive e noci, e gli spaghettoni con cacio pepe e baccalà, sono cose che non si dimenticano.
Ma è tempo di riprendere il cammino, e quello che avverti girando la pianura è il destino segnato di queste terre fertili, insieme all’imperativo ineludibile di rispettarle, se aspiriamo ancora a un futuro, ma è una cosa che manca, anche all’iniziativa pubblica. Basta andare alla stazione dell’Alta Velocità di Afragola, anche qui, una cattedrale nel nulla, non s’è capito perché, ci arrivi percorrendo poco più che una poderale, fino ai 4 ettari sterminati di parcheggio, tutta la fortezza avvolta da una rete divisoria, come fosse una base militare, senza uno straccio di inserimento, avverti il terrore del vuoto che l’attornia.
Il nulla attorno alla stazione non è un vuoto fisico. Anzi, i campi ancora coltivati che la bordeggiano sono un esperimento un po’ naif di landscape urbanism, di urbanistica rurale, ecologica, di paesaggio. Il vero vuoto attorno a questa stazione è il vuoto di regole, di terre affidate al sottobosco opaco dei passaggi di proprietà. È l’anomia. È un vuoto quindi che ribolle, magmatico, un vuoto di attesa, di un qualcosa che prima o poi dovrà verificarsi: al posto dei campi, nuovi parcheggi, piccoli e grandi hotel, resort, logistica, case. Ed è un vuoto di progetti da realizzare.
È per questo che per arrivare all’immaginifica opera di Zaha Hadid (che comunque, se la osservi da vicino, mostra già i suoi acciacchi, segno di un’italica scadente qualità esecutiva), devi uscire dalla statale e ficcarti sui tracciati di antiche strade campestri, oggi sbrigativamente asfaltate. Dalle terre in subbuglio di Parete la stazione dista venti minuti, da Giugliano poco più, attraverso il mitico Asse Mediano, segno viario dell’infrastrutturazione post-terremoto, oggi declassato a strada quasi urbana a servizio della dispersione insediativa tra Napoli e Caserta.
Luoghi che gravitano su Napoli, ma verso i quali Napoli volta le spalle. Di queste trasformazioni che incombono non si accorge l’urbanistica cittadina, ma nemmeno quella di area vasta, se il piano territoriale della Provincia di Caserta, che pure gli anticorpi e i dimensionamenti li aveva per contrastare queste cose, è stato messo sbrigativamente in soffitta, quello della Città metropolitana di Napoli è là da venire, col risultato che la pianificazione, quando c’è, resta miope, affidata ai soli comuni, ficcati nei loro confini amministrativi.
E invece i luoghi di questo racconto si vedono tutti, volendoli vedere: le villette international style di Parete per napoletani espulsi dal mercato immobiliare della loro città; i suoli in ibernazione attorno alla stazione dell’Alta Velocità. Persino le poche architetture di qualità e d’autore presenti vengono sacrificate. È il caso dell’edificio dell’Agenzia Brionvega di Franca Helg e Franco Albini ad Arzano, oggi imbrigliato in pannellature di plastica che ne hanno alterato l’aspetto. Oppure il destino dell’edificio ex Covit a Grumo Nevano progettato da Eduardo Vittoria e demolito qualche mese fa per far posto a palazzine da realizzare, ancora una volta, in deroga alle norme urbanistiche, con il consueto “piano casa”.
Sono luoghi che dichiarano la crisi della civiltà urbana, almeno così come l’abbiamo conosciuta e realizzata anche nel secondo ‘900. Quando si sono cimentati, lasciando un’eredità certo a volte complicata, architetti, paesaggisti, scuole di architettura e di ingegneria, sempre comunque in risposta ad una legge, un piano, una programmazione (Ina, 167, Pser, 219, Titolo VIII, ecc.). Oggi non più, in questa sterminata terra di mezzo, vige l’anomia e l’autonomia del fare, e il disordine tollerato oggi contiene in sé e in nuce l’immagine di questi territori sfortunati tra vent’anni. Difendere la terra, stabilire una volta per tutte dove passa il confine della città resta la soluzione. Attendere non è più dato.
Le cose cambiano

Antonio di Gennaro e Giuseppe Guida, 25 novemre 2023
In mezzo agli assilli e alle contrarietà della vita Port’Alba era un rifugio sicuro, quanto piacere e gratificazione c’era nell’esercizio di ricerca, la serendipità felice nel frugare delicatamente quell’arcipelago unico e imprevedibile di libretti, quante sorprese. Non avevamo capito quanto quell’ecosistema fosse delicato, fragile, ora che il meccanismo di competenze e tradizione s’è rotto, riprodurlo a tavolino non è cosa facile. Poi il pensiero si allarga, e rifletti che è solo un ulteriore segnale che la città sta cambiando, era rimasta ferma vent’anni, che ci piaccia o no le cose si sono rimesse in moto, velocemente.
Ora c’è il turismo, non è una nostra decisione, è lui che ha scelto noi, nel passa parola globale è giunto il nostro turno, anche qui, pensavamo che l’ecosistema grande che è il centro storico fosse robusto abbastanza, avesse la forza vitale e gli anticorpi per resistere a tutto, stiamo vedendo che non è proprio così, che ogni cosa è in gioco, nel bene e nel male. A far girare la macchina ci sono tre possenti motori – l’aeroporto, il porto, l’alta velocità – ancora una volta si tratta di forze che rispondono a input e processi più grandi di noi, la sensazione è che la decisione e il controllo non stiano proprio nelle nostre mani.
Poi è arrivato il flusso imponente di soldi del PNRR, lo slogan anche questa volta è stato “presto, che si perdono i soldi”, che per una buona programmazione non è proprio il massimo, speriamo che vada tutto bene, ma una strategia d’insieme sembra mancare, o comunque nessuno l’ha raccontata. Tra l’altro proprio le risorse per i pezzi di città più strategici ed importanti, Scampia e Taverna del Ferro, sembra stiano venendo meno per decisioni incomprensibili del Governo che, su questi temi, ha ostinatamente deciso di non cambiare idea.
Come sempre nella vita, ci sono differenze: se alcuni pezzi di città sono rapiti dal flusso vorticoso del mutamento, altri restano ai margini, a guardare. Così, i due grandi giacimenti del rinnovamento della città stanno immobili, Bagnoli e Napoli est, un capitale sterminato ostaggio di una bonifica all’italiana che non deve concludersi mai, tra propaganda e cinismo, e gli investimenti si tengono alla larga.
Nel frattempo i più giovani e i più bravi – che studino o lavorino – comunque vanno via, hanno deciso che non è più il tempo di aspettare.
Perché non manchi proprio nulla, una bella sballottata l’ha data madre terra, con la ripresa del bradisismo, un respiro millenario del suolo che c’è solo qui al mondo, e sarebbe l’occasione per ripensare Napoli nel territorio ampio che l’avviluppa, quel mosaico metropolitano fragile, squilibrato, gravido di sofferenze e risorse, anche quest’anno relegato in fondo alla classifica di qualità della vita, rispetto al quale un pensiero, l’indicazione di una possibile via di uscita ancora mancano.
In attesa di una visione istituzionale di area vasta, flussi di cose e persone di muovono comunque e l’aggressione ad uno dei territori più densi d’Italia è in corso: Arzano, Parete, Orta di Atella, Pomigliano d’Arco, Volla, ecc., stanno crescendo in un disordine edilizio che erode suolo agricolo per realizzare residenze prive di attrezzature, servizi, standard, per napoletani in fuga dai valori immobiliari alterati al rialzo nella loro città o per semplici investitori, spesso di aree grigie dell’economia.
Nei prossimi giorni i rappresentanti dell’Unesco saranno a Napoli per la loro conferenza sul “Cultural Heritage”, e la domanda è se saranno valutate queste dimensioni, o ci si limiterà ad uno sguardo zenitale e di facciata (nel senso costruttivo del termine) dell’area perimetrata del centro storico.
Tracciare una visione complessiva della città vuol dire pensare largo, nel tempo e nello spazio, sospinti da quella che il sociologo Carlo Donolo ha definito l’intelligenza delle istituzioni: enti pubblici che lavorano per il bene comune, che sono essi stessi beni comuni. Nel flusso impetuoso di mutamenti che ha rimesso in gioco la città, costruire le condizioni per restare, per non andare via, è questo il bene comune più importante.
Se la campagna non c’è più

Antonio di Gennaro, 9 settembre 2023
Il dibattito sul disegno di legge di modifica della legge urbanistica regionale entra nel vivo, come è giusto che sia. Tra i punti che necessitano di una ulteriore riflessione vi sono senza dubbio quelli relativi alla disciplina del territorio rurale che rischia di diventare, se il testo non dovesse mutare, una sorta di optional, un’area a statuto e destinazione incerti, dove tutto può ancora succedere, in contrasto con gli obiettivi di contrasto al consumo di suolo e alla dispersione insediativa, che pure il testo di legge dichiara di voler perseguire.
Il problema sta innanzitutto nelle definizioni. Diversamente da altre leggi regionali – pensiamo soprattutto alla Toscana e all’Emilia-Romagna – il disegno di legge campano istituisce tra la città e la campagna, tra il territorio urbanizzato e quello rurale, una sorta di terra di mezzo, lo spazio periurbano, che comprende sostanzialmente i paesaggi della campagna urbanizzata a bassa densità.
Nella legge toscana e in quella emiliana il territorio urbanizzato comprende solo la città densa, continua, consolidata, dove è giusto e opportuno procedere a tutte le riqualificazioni, recuperi, completamenti necessari. Al di fuori del confine della città consolidata inizia tout court il territorio rurale, che comprende, si badi bene, anche le aree di dispersione insediativa, e qui l’obiettivo è quello della tutela dei suoli non urbanizzati, la valorizzazione agricola multifunzionale, l’edificabilità rurale, sulla base di piani aziendali approvati dall’amministrazione, e basta.
Nel disegno di legge campano avviene per ora il contrario: in assenza di parametri, indici quantitativi misurabili, basta la presenza di pochi fabbricati e un minimo di urbanizzazioni nella campagna aperta per qualificare questi spazi come periurbani, ed allora può succedere di tutto, con la possibilità-limite che nei piani urbanistici la campagna come tale non esista più.
Questi timori sono tanto più giustificati in ambiti come quello della fascia metropolitana regionale, dove il 45% dello spazio è fatto di suoli fertili, con 20.000 aziende agricole che, attorno alla città, spesso dentro di essa, producono sul 15% della superficie coltivata il 40% del valore della produzione agricola regionale. Si tratta dei grandi sistemi rurali della campagna abitata: la piana campana, le colline flegree, i versanti vesuviani, i terrazzamenti della Penisola: paesaggi rurali storici, che in assenza di un ripensamento potranno cascare in larga parte nel limbo periurbano, ed allora che il Signore ci protegga.
Occorre nel disegno di legge un chiarimento profondo di prospettiva. Rispetto ai problemi posti dal cambiamento climatico, dal declino di biodiversità, dalla corrosione dei paesaggi storici, gli spazi agroforestali pregiati che fortunatamente rimangono attorno alla città, compenetrati con essa, sono la nostra assicurazione sul futuro, l’ecosistema di compensazione, regolazione e sicurezza che può aiutare la città a non collassare.
La disciplina di tutela gelosa di questo capitale naturale deve essere meglio declinata nel disegno di legge, con criteri certi, misurabili e verificabili. C’è tutto il tempo per migliorare: la campagna urbana con la sua complessità è parte di noi, pensiamo ai modi giusti per proteggerla, farla vivere ancora.
Le tre pacificazioni che attendono città

Antonio di Gennaro, 4 gennaio 2023
Con l’articolo importante di Laura Lieto, assessore all’urbanistica del comune e vicesindaca del comune di Napoli, pubblicato mercoledì scorso su queste pagine, riparte il discorso pubblico sul futuro della città. Il percorso proposto è una sintesi ragionevole di pragmaticità e strategia. Prima di tutto c’è la necessità di sbloccare/velocizzare le trasformazioni necessarie che il piano regolatore vigente già prevede, soprattutto nella zona orientale. Lo strumento è una variante normativa, da approvare nei tempi brevi. Poi c’è la visione del futuro, con un’agenda articolata di strategie, obiettivi, progetti guida, il tutto sintetizzato in un “Documento strategico per una città giusta, sostenibile e attrattiva”, attualmente all’esame della Commissione urbanistica del Consiglio comunale.
Nel suo articolo l’assessore Lieto giustamente sottolinea l’importanza del processo di ascolto, confronto, partecipazione che da questo momento si avvia, con lo scopo di dotare la città del nuovo piano urbanistico.
Le prime riflessioni, a caldo, riguardano tre urgenze indifferibili, che meritano un’attenzione ulteriore, e che proviamo schematicamente a sintetizzare così: per voltare veramente pagina la nostra città ha bisogno di una triplice pacificazione: con il territorio metropolitano, con i suoi 30 quartieri, con i suoi abitanti di oggi.
Nessun discorso di attrattività può arrestarsi dentro i confini cittadini. La soluzione dei problemi più urgenti (abitazione, rifiuti, trasporti, impianti tecnologici, rischi ambientali ecc.) è perseguibile solo alla scala metropolitana. D’altro canto, ci piaccia o meno, è alla scala metropolitana che gli osservatori esterni, dalla stampa specializzata alla commissione europea, misurano la qualità del nostro sistema di vita e assegnano i loro ranking. Al momento Napoli e il restante territorio metropolitano non si fidano l’uno dell’altro, si guardano con sospetto, sfiducia, la rivendicazione prevale sul senso di cooperazione.
Tornando a noi, all’interno dei suoi confini Napoli rimane un’aggregazione provvisoria di villaggi. Eppure, molti dei suoi quartieri, per peso demografico e territoriale, sono vere e proprie città nella città, ciascuna con un proprio carattere, uno specifico cahier di sofferenze, bisogni, necessità. Per riabbracciare finalmente questo universo complesso all’interno di un destino comune è necessario dimostrare a ciascuna realtà territoriale, numeri alla mano – da Pianura a S. Giovanni, passando per Scampia e S. Pietro a Patierno – che si sta anche operando in direzione di un loro beneficio concreto, di una risposta alle specifiche esigenze locali.
In ultimo, ogni discorso sul futuro deve partire dal riconoscimento delle condizioni difficili e dall’incertezza di prospettive che i napoletani di oggi vivono quotidianamente. Soprattutto nei confronti delle fasce giovani di popolazione la città non è mai stata tanto spietatamente avara. L’articolo dell’assessore Lieto dedica a questi aspetti lo spazio doveroso, ci sembra solo che, prima di pensare all’attrattività per “nuove popolazioni”, la priorità rimanga quella di dare risposta ai cittadini di oggi, offrendo un percorso misurabile di miglioramento dei servizi essenziali, quartiere per quartiere. Sarà un percorso graduale e difficile, nessuno può reclamare miracoli, ma qualche obiettivo verificabile bisogna pure stabilirlo.
Nel lavoro che ci attende verso la costruzione del nuovo piano della città, queste tre pacificazioni, queste tre alleanze da costruire con l’hinterland, i quartieri e i cittadini di oggi, saranno la cartina al tornasole per misurare e selezionare le reali priorità, migliorando e riammagliando l’esistente, mettendo a frutto quanto il PRG già consente, curando e rispettando i suoli della città, riconducendo al governo cittadino il controllo di aree e processi fondamentali, a partire da Bagnoli.

Antonio di Gennaro, Repubblica Napoli 25 luglio 2023
E’ un librino fondamentale per capire cos’è il paesaggio quello che Paolo Carpentieri, Carlo Iannello e Giancarlo Montedoro hanno scritto (“La concezione crociana di paesaggio nel diritto contemporaneo”, prefazione di Piero Craveri, Editoriale Scientifica, 112 pagine). E non fatevi sviare dal tono accademico del titolo: è un testo scritto semplice, godibile, che dovrebbero leggere tutti, e comunque ha ragione Piero Craveri quando scrive in prefazione che su questi temi “… molte cose sono state dette ma nessuna, a mio giudizio, con la profondità analitica di queste tre relazioni… in cui gli aspetti giuridici costituiscono un punto focale e hanno il necessario approfondimento.”.
Gli autori sono tre giuristi che al paesaggio hanno dedicato una parte importante della loro attività scientifica, istituzionale, didattica, ma sin dalle prime righe appare evidente al lettore come questo libro sia in qualche misura diverso da lavori precedenti, perché più di altri sembra nascere da un’urgenza democratica, in un momento storico nel quale il paesaggio italiano è sotto attacco.
Come ricorda Montedoro nel primo dei tre interventi, con i soldi del PNRR ci accingiamo a destinare una parte importante dei paesaggi rurali del Paese all’installazione di impianti industriali per la produzione energetica da fonti rinnovabili, ma “… la transizione energetica avviene senza il ricorso a strumenti di pianificazione territoriale. Si tratta di una grande lacuna legislativa suscettibile di produrre danni proprio a carico delle nuove generazioni che rischiano di non vedere più il paesaggio agrario pugliese o la dolcezza delle colline toscane, umbre o marchigiane nel loro aspetto tradizionale.”
Insomma, per la Repubblica italiana è un passaggio decisivo, considerato che la tutela del paesaggio, come scritto nell’articolo 9 della Costituzione, è uno dei valori e principi fondativi.
Si capisce bene allora come il ritorno a Croce non abbia nulla di nostalgico, accademico, elitario, ma risponda a un’esigenza del tutto pratica: quella di fare chiarezza sul significato autentico e sul valore originale e autonomo del paesaggio come patrimonio identitario, come modo di percepire, vivere, assegnare valore e significato ai luoghi che abitiamo – i territori rurali come le città – nella continuità di lunga durata della nostra storia e della nostra cultura.
Come scrive Carlo Iannello, è questa l’idea di paesaggio, attualissima, sulla quale Croce costruisce la sua legge del 1922, la prima che lo stato unitario riesce finalmente a darsi, vincendo le resistenze della grande proprietà fondiaria che si sentiva minacciata, affermando invece l’interesse pubblico che il paesaggio riveste, e la necessità ineludibile che lo Stato dica la sua sulle trasformazioni che riguardano il patrimonio culturale comune.
Si tratta, come emerge dall’excursus godibilissimo di Iannello, dei principi, delle basi concettuali sulle quali sono stati successivamente pensati e definiti tutti gli strumenti normativi che l’Italia si è data, dalla legge Bottai del ’39, al decreto Galasso dell’85, al Codice dei beni culturali del 2004, e delle quali anche la Convenzione europea del paesaggio siglata a Firenze nel 2000 alla fine è tributaria.
Certo, come sottolinea Paolo Carpentieri nel saggio finale del libro, rimane la difficoltà di regolare i rapporti non semplici tra tutela del paesaggio, governo del territorio e tutela dell’ecosistema, nel puzzle di competenze che la cattiva riforma del titolo quinto ha contribuito a esacerbare, ma non è confondendo queste cose diverse che il Paese salverà i suoi paesaggi: insomma, anche nella frenesia realizzativa del PNNR, è bene che il paesaggio come principio autonomo conservi la sua forza e ragion d’essere, e su questo il filosofo di Pescasseroli ha ancora maledettamente ragione.

Il romanzo della periferia dimenticata. Una storia di cinquant’anni fa che ci parla di problemi non ancora risolti
Antonio di Gennaro, Repubblica Napoli 16 maggio 2023
Si presenta domani, presso la sala “Silvia Ruotolo” in Via Morghen 84, alle ore 17.00, il romanzo di Pio Russo Krauss “Come la luce dell’alba”, La Valle del Tempo Edizioni. Intervengono con l’autore, oltre al sottoscritto, Silvio De Majo, docente di Storia contemporanea e Storia economica presso l’Università Federico II di Napoli, e Paolo Siani, coordinatore del tavolo “Infanzia e Adolescenza” del Comune di Napoli e consigliere della fondazione “Giancarlo Siani”. Titti Pepi leggerà brani del romanzo.
Il romanzo è la storia di un giovane sacerdote, padre Sergio, nella Pianura di cinquant’anni fa, il momento in cui la vita collettiva del casale agricolo millenario viene sconvolta dall’ingresso brusco e drammatico nella modernità, che in queste campagne ha il volto dell’abusivismo, la costruzione febbrile, al di là di ogni regola, sulle terre nere più fertili del globo, di un intero quartiere-città che nessun piano aveva previsto, che oggi ospita più di 40.000 abitanti.
All’inizio del romanzo c’è il cadavere di un colono, s’è impiccato a Masseria Grande nella rimessa scalcinata dietro il vecchio noce, il giovane prete è lì davanti al povero corpo penzolante, impietrito, tra le donne che gli implorano distrutte una benedizione. Scoprirà presto che alla base del suicidio c’è un ricatto spietato, emissari dei costruttori stanno girando i poderi obbligando i coloni analfabeti a sottoscrivere subdolamente lettere di scioglimento del contratto secolare di mezzadria.
Inizia così, drammaticamente, la presa di coscienza di padre Sergio, e il libro è la storia dell’impegno di questo prete ragazzo per organizzare una difesa degli agricoltori minacciati, il suo tentativo di fare della parrocchia dei Frati Agostiniani, in mezzo al casale dimenticato, un luogo di accoglienza e riscatto, scotendo dal torpore confratelli e superiori, aggregando i giovani, aprendola ai bambini delle baracche senza acqua e senza servizi, per un minimo di doposcuola, una visita medica, un’attenzione sconosciuta.
Tutto questo nella Napoli del 1973, una città ribollente di nuovi fremiti e antichi contrasti, che Russo Krauss riesce assai bene a rendere e ricostruire, tra l’epidemia di colera, il referendum sul divorzio, il declino industriale a est e a ovest, l’ascesa delle sinistre e le resistenze democristiane, ancora poco e sarebbe iniziata l’esperienza esaltante e difficile della giunta Valenzi.
Ancora, sono gli anni nei quali inizia a imporsi la questione ambientale, della prima crisi petrolifera, l’austerità, le domeniche a piedi. Nella Chiesa cattolica è il tempo esaltante dell’apertura post-conciliare, del rinnovamento liturgico, della richiesta da parte dei laici di nuovi ruoli e responsabilità, nuovi modi di vivere ed esprimere la stessa fede.
Nel romanzo di Pio Russo Krauss ci sono tutte queste cose, attraverso la storia quotidiana, come l’avrebbero raccontata Manzoni o Tolstoj, del gruppo di uomini e donne che attorno a padre Sergio sono chiamati alla scelta decisiva tra il lasciar correre e il mettersi in gioco, andando controvento, contro l’inerzia delle istituzioni, lo scetticismo maggioritario, la spietatezza degli interessi. Ma anche la difficoltà di far lavorare e dialogare insieme su obiettivi comuni di riscatto – è una delle fatiche maggiori che Sergio dovrà affrontare – le diverse forze del cambiamento possibile.
Il finale è aperto: come è inevitabile, padre Sergio si troverà da solo a rispondere delle sue scelte, tra queste l’amore per la ragazza che ha scelto di stargli accanto in mezzo alle difficoltà; pagherà tutti i prezzi, ma l’impegno e la fede resteranno.
In questo libro la storia ti prende e non ti lascia più, e ti accorgi alla fine che con il suo romanzo Pio Russo Krauss è riuscito in un’impresa non semplice: ricordare che ci sono momenti decisivi nella vita della città e degli uomini che la abitano, nei quali hai la sensazione che la storia possa cambiare il suo percorso; riconoscere oggi che le domande e le urgenze rimaste sul tavolo, sono ancora quelle alle quali allora non riuscimmo a dare una risposta.


Antonio di Gennaro, Repubblica Napoli del 30 marzo 2023
Si presenta oggi alle 16, nella sala “Catasti” dell’Archivio di Stato, il libro di Vezio De Lucia “L’Italia era bellissima. Città e paesaggio nell’Italia repubblicana”, DeriveApprodi editore, con gli interventi della direttrice dell’Archivio Candida Carrino, del giornalista Francesco Erbani e di Laura Lieto, assessore all’urbanistica e vicesindaco del comune di Napoli, moderati dalla storica dell’ambiente Gabriella Corona direttrice dell’ISMED- CNR.
Nel libro c’è il racconto agile e denso, 120 pagine che si leggono d’un fiato, del percorso difficile e contrastato lungo il quale la giovane repubblica ha guidato il paese nel passaggio brusco alla modernità: i pochi cruciali decenni, a partire dal secondo dopoguerra, nei quali il volto e l’organizzazione territoriale dell’Italia sono mutati irreversibilmente, dall’assetto rurale millenario, a quello odierno, metropolitano, dell’ottava economia mondiale.
L’importanza del libro sta nel fatto che non si tratta di una ricostruzione asettica, perché all’urbanistica e alle politiche per paesaggio e l’ambiente Vezio De Lucia ha dedicato l’intera vita professionale, amministrativa, politica, spesso con ruoli rilevanti, e allora molto del fascino e del calore che il racconto sprigiona sono proprio legati al carattere di testimonianza diretta, critica, apertamente schierata sulle vicende narrate, con l’obiettivo di tentare un bilancio, ma anche di indicare, nonostante le difficoltà, frustrazioni e battute d’arresto, una direzione futura possibile.
Nel racconto, un ruolo importante lo hanno le figure notevoli che De Lucia ha incontrato, che lo hanno ispirato, a fianco delle quali ha lavorato e lottato, su tutte quelle di Antonio Cederna, cui è dedicato un intero capitolo, e poi Eddy Salzano e Italo Insolera, le cui foto in bianco e nero nella sezione finale del libro visualizzano con straordinaria efficacia molti dei temi affrontati.
I fili che la narrazione segue sono molti, ma quello principale è legato all’incapacità drammatica, mostrata dalla Repubblica italiana nei suoi quasi ottant’anni anni di vita, di dotare il paese, sull’esempio delle altre democrazie liberali europee, di una disciplina nazionale sull’uso e la pianificazione dei suoli, in sostituzione della legge urbanistica fondamentale, che continua a rimanere quella promulgata dal regime fascista nel 1942.
Nelle democrazie europee di maggiore tradizione, a partire da quella inglese, il fatto che il suolo non sia un bene di mercato come un altro, ma una risorsa irriproducibile, disponibile in quantità limitata, sul cui utilizzo l’autorità pubblica debba mantenere una potestà superiore, a garanzia dell’interesse e del benessere collettivo, è ritenuta la precondizione affinché una vera economia di mercato possa svilupparsi. Principi sacrosanti, che in realtà sono presenti anche nella nostra Costituzione, in un pugno di articoli aurei – 3, 9, 32, 42, 43 – dai quali non è però mai scaturita da parte del parlamento una legislazione ordinaria conseguente.
Quello che rimane in Italia, dopo la riforma del Titolo V, è un mosaico disforme di leggi regionali la cui somma, è evidente, non è in grado minimamente di definire quell’idea unitaria e coerente di paese della quale abbiamo bisogno per convivere e competere nel contesto globale, e per assicurare ad ogni cittadino, sostenibilmente, la giusta quota di beni e servizi pubblici.
Preso atto di questo quadro di debolezza complessiva, la proposta di De Lucia per il futuro è improntata a un assai ragionevole pragmatismo operativo: per chi volesse in Italia spendersi ancora per la pianificazione pubblica delle risorse ambientali, dei paesaggi, dello spazio di vita delle persone, è inutile a questo punto puntare su nuove leggi, quanto sull’uso intelligente di quelle che già ci sono, a partire da ciò che rimane dalla legge fondamentale del ’42, dai principi importanti contenuti nel Codice del paesaggio del 2004, dall’integrazione delle leggi specialistiche per la difesa del suolo e per le aree protette, che pure sono una conquista importante dell’ultimo scorcio di ‘900.
Questo vale anche e soprattutto per Napoli. In più occasioni nei suoi interventi pubblici il vicesindaco Laura Lieto, che è anche assessore all’urbanistica e interverrà come detto nella presentazione del libro, ha affermato che il piano regolatore vigente è stato e rimane una risorsa per la città, con la sua visione di tutela delle aree verdi e del centro storico, e di trasformazione delle aree industriali dismesse a oriente e occidente della città. Quel piano, che ha decretato lo stop al consumo di suolo, è stato pensato all’inizio degli anni ’90, quando Vezio De Lucia ha ricoperto per poco più di tre anni la carica di assessore all’urbanistica nella prima giunta Bassolino.
E’ evidente dopo trent’anni, in questo mondo nuovo nel quale ci tocca vivere, profondamente mutato dalla crisi climatica, la pandemia, lo sviluppo della rete, gli assestamenti imprevisti nei rapporti internazionali, che l’amministrazione debba impegnarsi nella redazione di un nuovo piano urbanistico comunale, rinnovando la strategia di tutela attiva dei beni pubblici e del patrimonio storico, e liberando finalmente le trasformazioni a Bagnoli e a Napoli Est, intrappolate da una bonifica autoreferenziale all’italiana, che non ha mai termine, guardando alla scala metropolitana dei problemi e delle soluzioni. Perché alla fine, come scrive De Lucia nelle righe finali del volumetto, l’urbanistica contemporanea deve essere conservatrice e rivoluzionaria, come il partito pensato da Enrico Berlinguer.
Si inizia domani mattina, lunedì 30 gennaio, al Dipartimento di Agraria di Portici, con la presentazione del libro di Alessandro Santini “La bonifica e lo sviluppo dell’agricoltura nell’Italia meridionale“, edito da Doppiavoce. Un’opera destinata a durare, ampia, documentata, corredata da un’iconografia fantastica. Il racconto del lavoro secolare di trasformazione del territorio attraverso la bonifica e l’irrigazione, nel quale istituzioni, politica, scienza, tecnica e cultura per una volta si sono messe insieme, in un filone che parte da Antonio Genovesi e arriva a Manlio Rossi-Doria, passando per gente Giuseppe Maria Galanti, Giustino Fortunato, Francesco Saverio Nitti, Eugenio Azimonti, Arrigo Serpieri, Emilio Sereni. Un filone culturale che è tutt’uno col migliore meridionalismo, caratterizzato da un’attenzione unica, ante litteram, alla gestione sostenibile delle risorse come premessa per il benessere sociale.
Quindi venerdì pomeriggio, 3 febbraio, a Pianura, per iniziativa del “Corriere di Pianura” si ragione di suolo, campagne urbane e periferie a partire da due libri: “Sette pezzi facili” (Clean ed.) del quale abbiamo già parlato sul blog, e il libricino prezioso di Paolo Pileri “L’intelligenza del suolo” (Altreconomia ed.). Con Paolo ci saremo io e Giuseppe Guida, il vicesindaco e assessore all’urbanistica Laura Lieto, il direttore del Corriere di Pianura Antonio di Maio. Sarà un bel pomeriggio, l’occasione per dialogare e ragionare con i cittadini di Pianura.
Ecco le locandine dei due incontri.



Antonio di Gennaro e Giuseppe Guida
Un viaggio nei luoghi simbolo della città, lungo un itinerario in sette tappe, dai grattacieli fantasma del Centro direzionale svuotato, ai paesaggi mondiali di Posillipo distrutti dalla cocciniglia e dall’incuria, al limbo delle aree industriali estinte, a est e a ovest della città, ai quartieri informali ed abusivi. Un racconto pieno di sorprese e imprevisti, pubblicato a tappe sull’edizione napoletana del quotidiano “La Repubblica” con le foto straordinarie di Riccardo Siano, nell’anno secondo di pandemia. Il libro è pubblicato da Clean edizioni ed è fatto di sette pezzi solo in apparenza facili, che riguardano argomenti complicati: il destino di luoghi urbani importanti, lasciati in sospeso, dimenticati, interrotti, insieme alle proposte per rimetterli in gioco, restituirli ai cittadini, ripartendo dal quotidiano, dal temporaneo, dalle cose che possiamo fare oggi, in attesa del meglio.
Ecco la premessa degli autori.
Un urbanista e un agronomo in giro per Napoli. L’intenzione era quella di raccogliere idee, per contribuire al dibattito pubblico su come rimettere in cammino una città sospesa, interrotta, dopo un ventennio di governo stentato, a bassa intensità. È iniziato così il viaggio nei luoghi simbolo della città, nel secondo anno di pandemia, raccontato in sette reportage pubblicati sull’edizione napoletana de la Repubblica, ma anche sul sito web del quotidiano nazionale, a testimonianza di un’attenzione particolare del giornale per i fatti della terza città d’Italia.
Un itinerario in sette tappe, dai grattacieli fantasma del Centro direzionale svuotato dal Covid, ai paesaggi mondiali di Posillipo distrutti dalla cocciniglia e dall’incuria; al limbo senza prospettive delle aree industriali estinte, a est e a ovest della città. Su molte di queste cose avevamo già scritto nel corso degli anni, ciascuno per proprio conto, sempre su Repubblica, ma questa volta occorreva qualcosa di diverso: nel nuovo mondo, del quale anche Napoli evidentemente è parte, scosso dal crack del clima e dal virus globale, dall’irruzione della rete, dalla corrosione della fiducia e della democrazia, almeno come l’avevamo sperimentata nel ‘900; in questo mondo nuovo, per non ripetere inutilmente le stesse parole di prima, bisognava mescolare saperi e punti di vista: muoversi in territorio incognito, per leggere con occhi quanto più possibile sgombri, quel che accade nelle realtà diverse che confluiscono in quella cosa complicata che sbrigativamente chiamiamo “Napoli”.
Il linguaggio e gli strumenti sono naturalmente quelli del giornalismo. I pezzi raccolti in questo volume non sono saggi, ma articoli per i lettori del giornale; ciò che abbiamo fatto semplicemente è scendere in strada, zaino in spalla, per osservare ed esplorare i luoghi, parlare con le persone, respirare i paesaggi, e raccontare tutto in modo diretto, cercando il più possibile di mettere da parte gerghi, specialismi, messaggi rituali per addetti ai lavori. Le foto che Riccardo Siano ha scattato per il giornale, percorrendo assieme a noi i luoghi, sono un elemento essenziale della storia, che spesso comunica più e oltre le parole.
Al ritorno dal viaggio, due o tre cose avevamo soprattutto compreso. La prima riguarda il potenziale umano, l’attaccamento ai luoghi, la capacità delle persone e dei contesti di riorganizzarsi e adattarsi, di costruire pezzi di futuro, anche in assenza di un governo urbano e di un progetto comune. Questo è vero nella città abusiva di Pianura, come nella periferia industriale rarefatta di San Giovanni Barra Ponticelli, o in quella interna, incredibilmente densa, del centro storico: nel deserto della rete istituzionale, si muove tutto un mosaico di iniziative e storie collettive, si tratti di far rivivere la vigna antica dei Certosini sui terrazzamenti medievali di San Martino; di aprire una scuola di frontiera nei Quartieri spagnoli; di costruire orti sociali a Ponticelli, in mezzo al grade parco pubblico in rovina, per combattere marginalità e dipendenze; o di produrre cocciutamente un giornale di quartiere per perpetuare nonostante tutto una storia locale, una prospettiva.
Assieme a questo, la constatazione di quanto sia ancora fragile l’imbastitura che tiene insieme le molteplici tessere che formano il grande mosaico della città. A un secolo di distanza dall’accorpamento alla Grande Napoli della cintura dei casali – da San Giovanni a Pianura, fino agli anni ‘20 del secolo scorso comuni autonomi, con la loro storia, cultura, economia – un progetto unitario di città, ancora stenta ad affermarsi. Nel frattempo i borghi si sono tumultuosamente trasformati in centri urbani di 40, 50, 60mila abitanti, vere e proprie città nella città, ma un’agenda di governo, una strategia amministrativa che tenga conto delle necessità basilari di ciascuno di questi mondi, così diversi tra loro, per associarli finalmente in un’unica comunità di destino, ancora non c’è: la cosiddetta “città dei quindici minuti”, come si dice ora, resta una chimera, e Napoli continua a presentarsi come un’aggregazione provvisoria di villaggi. Alla fine, girando la città, risulta evidente come senza una strategia pubblica che tenga insieme tutto, la resilienza e l’impegno ammirevole di individui e comunità locali da soli non bastano, mentre rimane insopportabilmente largo lo scarto tra l’incredibile capitale umano, territoriale, culturale e simbolico del quale la città continua nonostante tutto a disporre, e le condizioni di vita reali dei cittadini. 17
Un esempio per tutti, l’accessibilità delle aree verdi. Come raccontato nei reportages raccolti nel libro, durante l’epidemia, nelle città del mondo l’uso di parchi e giardini urbani è raddoppiato, a volte triplicato, in risposta alla nuova domanda di spazi aperti di salute e socialità per i cittadini, soprattutto i più piccoli, i giovani, gli anziani.
A Napoli è successo il contrario, l’azzeramento della macchina gestionale e manutentiva del Comune ha portato alla decisione opposta, la chiusura pressocché totale degli spazi verdi, che è suonata come la dichiarazione di resa dei poteri pubblici, condannando la cittadinanza a vivere la forma più desolante di povertà: quella di chi non possiede più nemmeno la forza e la capacità di accedere al patrimonio di risorse che pure gli appartiene, che gli è vicino, ma resta lì, chiuso dietro un cancello, come il bosco appenninico di cento ettari dei Camaldoli, una foresta urbana straordinaria che entra dentro la città, e marcisce silenziosamente nell’incuria.
A Napoli il metabolismo urbano s’è bloccato. Il riciclo delle vastissime aree dismesse 90, 50, 30 anni fa dall’industria novecentesca, che in tutte le città un minimo governate si sarebbe fatto laicamente, senza tanta retorica, con una sobria e rapida messa in sicurezza, qui si è trasformato in un’opera pubblica a perdere, che non finisce mai, che non deve dar conto di sé, bruciando laidamente soldi pubblici, speranze e prospettive. Le eccezioni non sono molte, come il recupero a San Giovanni a Teduccio dell’ex area Cirio, che ora ospita il campus di Ingegneria. Eppure, i reportages nel libro raccontano come, se solo lo volessimo, il sortilegio potrebbe svanire in un attimo, semplicemente aprendo il cancello del parco provvisorio nell’ex area siderurgica di Bagnoli, che la natura con i suoi alberi ed erbe ha già costruito e messo in sicurezza per noi. Poter calpestare nuovamente queste terre è un buon esercizio di democrazia, e un’esperienza urgente, tenuto conto che la vita è breve – nel lungo termine Keynes ci ha ricordato cosa succede – e in ogni caso è bene che l’aria torni a circolare, il resto verrà.
Rileggendo a distanza di tempo gli articoli, ci siamo resi conto di quanto abbia pesato la pandemia. Abbiamo iniziato il viaggio che un vaccino e una cura non c’erano, e un senso di fragilità traspare in tutte le parole che abbiamo scritto. La malattia globale non è un ospite di passaggio, ma un protagonista nel nuovo mondo che ci attende: la vita delle persone e dei luoghi che abbiamo raccontato dovrà ancora fare a lungo i conti con essa. Così come è parte del viaggio il sentimento di gratitudine e riconoscenza provato al momento della vaccinazione, segno tangibile, esemplare del potere dell’azione pubblica, della conoscenza e della democrazia, quando sono chiamate a proteggere la vita delle persone.
Quanto al titolo, riecheggia evidentemente i “Sei pezzi facili” del fisico Richard P. Feynman, il libricino di Adelphi con il testo delle lezioni tenute dall’autore nei primi anni ‘60, su concetti di base come l’energia o la realtà quantistica, con parole e ragionamenti semplici e piani. Insomma i pezzi sono facili, ma gli argomenti difficili. Con le debite proporzioni, anche il libretto che proponiamo è minuto, e tratta di cose importanti – il destino di parti fondamentali della città – cercando di raccontare in modo semplice storie piuttosto complicate, o che sarebbero anche semplici, se avessimo la capacità di affrontarle con più coerenza e costanza. La parola “pezzi” poi, allude sia agli articoli di stampa raccolti nel volume, sia ai pezzi della città che vengono raccontati, ognuno abbandonato a una sua particolare deriva, spezzato dal contesto, in attesa.
Resta da dire qualcosa sulla scrittura del libro. I sette racconti tutto sommato scorrono, il lavoro a quattro mani non si avverte troppo, senza che ci sia stato bisogno, ripensandoci, di un’opera di raccordo particolare. Certo di ragionamenti ne abbiamo fatti, nella scelta dei luoghi, e poi sul campo, mentre l’esplorazione si svolgeva, con tutte le sorprese e gli imprevisti del caso. Ma poi ognuno tornava a casa, e scriveva le cose che credeva. Il fatto sorprendente è come poi i testi si combinassero con facilità, senza bisogno di chissà quali tagli o ritocchi. Comunque, se pure in queste diverse parti una differenza di vedute veniva fuori, non siamo stati lì troppo a smussarla, il lettore forse se ne accorgerà: in fondo, come proponeva Calvino nelle sue lezioni per il prossimo millennio, anche la molteplicità di sguardo può essere uno strumento utile, in questo mondo nuovo e incerto che ci tocca vivere.

Antonio di Gennaro e Fabrizio Cembalo Sambiase
Nel febbraio del 2020 con Fabrizio intervenimmo a Treviso al convegno della Fondazione Benetton dal titolo promettente: il suolo come paesaggio. Eravamo in piena tempesta e non lo sapevamo, al rientro a Napoli l’emergenza Covid è esplosa. Ora gli atti del convegno sono stati pubblicati a cura di Luigi Latini e Simonetta Zanon da Antiga edizioni. Ecco il testo del nostro intervento.
Se provi a digitare su Google la parola “terra”, è l’algoritmo a completare la frase, e tra le primissime opzioni compare proprio “terra dei fuochi”. È una conferma della risonanza mondiale delle vicende della piana campana massacrata dall’abusivismo e dai rifiuti, tanto da fare della locuzione un simbolo, un luogo comune, uno stereotipo. Qualcosa che viaggia nel discorso pubblico globale, spogliata alla fine di ogni aspetto misurabile, tecnico, territoriale. La cosa singolare è il fatto che sia stata alla fine l’agricoltura il principale imputato, anche se dopo sei anni neanche uno delle migliaia di campioni di prodotti agricoli analizzati ha rivelato problemi. Circoscrivere il problema è essenziale per definire le possibili soluzioni. Il modo generico ed emotivo con il quale questa questione è circolata sui social network è proprio quello giusto per allevare paure, guardandosi bene dall’indicare possibili strade d’uscita. Quello che abbiamo capito, alla fine, è che la Terra dei fuochi è una malattia del paesaggio. Malattia generata dall’assenza di pianificazione pubblica. Le 140 città intorno al capoluogo partenopeo si sono saldate in un’unica, informe periferia lunga 90 chilometri. In questa città malcresciuta sono rimasti intrappolati i lacerti di Campania felix, i suoli agricoli più fertili della galassia, con 20.000 aziende agricole che, su meno del 10% della SAU (Superficie Agricola Utilizzata) producono il 40% del valore della produzione agricola regionale. Terra dei fuochi è la tragedia dei due milioni di italiani che vivono faticosamente questo spazio che sfida l’umana comprensione. In questa situazione complessa, abbiamo lavorato a numerosi progetti di paesaggio per curare le ferite: gli spazi agricoli mortificati, le cave, le discariche. Alcuni di questi luoghi simbolo, come l’ex Resit di Giugliano, la “madre di tutte le discariche”, ora sono spazi verdi pubblici, abbelliti dai murales di Jorit e dalle istallazioni di land art degli studenti del Liceo artistico di Napoli. Lì vicino, nel podere di San Giuseppiello, dove i camorristi sversavano i fanghi delle concerie toscane, un bosco di 20.000 pioppi lavora per tenere in sicurezza i suoli e le terre. È un laboratorio verde all’aperto in continuo progresso, dove migliaia di studenti delle scuole pubbliche della Campania vengono a studiare e comprendere come si ricostruiscono i suoli e gli ecosistemi, restituendo dignità ai luoghi, e un futuro diverso alle comunità che li abitano.
Il territorio rurale metropolitano come “spazio vuoto”
L’agricoltura e gli agricoltori dell’area napoletana sono presenze invisibili, vittime di un mutamento epocale. Nell’ultimo sessantennio, l’esplosione della città sulle terre fertili della piana ha mutato per sempre un assetto territoriale che resisteva ancora a metà Novecento, e che costituiva il risultato di tre millenni di civiltà. A scala metropolitana, le aree urbanizzate, in assenza di una qualunque pianificazione pubblica, passano dai 20.000 ettari del 1960, ai 120.000 ettari attuali. Nel 1960, i centri urbani erano ancora isole compatte, a confini netti, all’interno di un mare di ruralità, con gli stessi paesaggi che aveva visto Goethe arrivando in carrozza da Roma, in un inverno di due secoli fa. Dopo la deflagrazione, le aree agricole si frammentano, diventano isole verdi incastrate nella maglia delle infrastrutture e dello spazio costruito. Il loro statuto diventa quello indefinito di spazi vuoti, per usare l’espressione di Bauman: “Gli spazi vuoti sono innanzitutto e soprattutto vuoti di significato. Non sono insignificanti perché vuoti: sono piuttosto visti come vuoti (o più precisamente non vengono visti affatto) perché non presentano alcun significato e non sono ritenuti in grado di presentarne uno… …Gli spazi vuoti…sono luoghi non colonizzati e luoghi che nessuno desidera o sente la necessità di destinare alla colonizzazione. Sono, potremmo dire, i posti “restanti” una volta completata l’opera di strutturazione degli spazi più appetibili … La vacuità del luogo è negli occhi di chi guarda e nelle gambe o nelle ruote di chi procede. Vuoti sono i luoghi in cui non ci si addentra e in cui la vista di un altro essere umano ci farebbe sentire vulnerabili, a disagio e un po’ spaventati.”
Questa agricoltura che è intorno alla città, spesso dentro la città, è invisibile all’opinione pubblica, ma anche alle istituzioni. A causa della sua estrema frammentazione, non viene nemmeno più rilevata dall’istat. Nel censimento dell’agricoltura 2010, meno della metà delle aree agricole effettivamente presenti viene censito. Il resto sfugge alla contabilità territoriale dello stato, è territorio invisibile, in attesa di destinazione.
La realtà, al di là delle statistiche stanche dell’istat, è sorprendente. Nonostante gli scempi del passato, il 60% dell’area metropolitana è ancora campagna, con coltivazioni agricole, frutteti, boschi, aree seminaturali, dal lago Patria a Punta Campanella, passando per le colline flegree e il Vesuvio. Un patrimonio rurale straordinario, che costituisce la parte pregiata del tessuto metropolitano.
Ancora, a dispetto di questo clamoroso difetto percettivo, i numeri veri raccontano invece di un’agricoltura della piana campana che, seppur incastrata nei vuoti del disordinato sistema metropolitano, è ancora viva, con un sistema di 38.000 aziende attive, che producono il 40% del valore aggiunto dell’agricoltura regionale, con valori di produzione unitari che sono tre volte la media regionale. Il motore dell’agricoltura regionale, nonostante tutto, è ancora qui.
La salubrità delle produzioni di questa agricoltura degli spazi vuoti – pregiatissime fragole, meloni, insalate, asparagi, pesche mele, cavoli, patate – che pure continuano ad essere acquistate in prevalenza dalla grande distribuzione, e viaggiano lungo le filiere lunghe di mezzo mondo, è stata recentemente messa in dubbio, a causa di possibili contaminazioni dovute ai rifiuti. L’assoluta diffidenza dei consumatori ha imposto per le produzioni della piana campana, una commercializzazione in forma anonima, con quotazioni ricattatorie, inferiori anche del 75% rispetto a quelle correnti, perché lo slogan imperante negli esercizi commerciali è “qui non si vendono prodotti campani”. Prese nella morsa del ricatto le aziende agricole chiudono, e lo spazio agricolo periurbano, in assenza di presidio e manutenzione, rischia di trasformarsi rapidamente in un deserto economico e sociale, una terra di nessuno, disponibile per ogni tipo di speculazione e manomissione.
Eppure, i rigorosi controlli effettuati dicono il contrario: i suoli agricoli contaminati identificati dal gruppo di esperti ministeriale assommano ad una trentina di ettari, mentre gli oltre 5.000 controlli effettuati sulle produzioni, ne hanno evidenziato la completa sicurezza e conformità alle leggi.
In definitiva, le conoscenze delle quali disponiamo consentono di affermare che la piana campana deve sì considerarsi un pezzo di territorio scombinato e sconquassato da un cinquantennale saccheggio, ma soffre alla fine degli stessi mali delle altre pianure italiane ed europee a comparabile grado di antropizzazione e urbanizzazione. Si tratta certo di un contesto nel quale le attività agricole devono faticosamente convivere con un sistema urbano fuori controllo, ma almeno sotto il profilo della sicurezza alimentare l’inferno non abita qui, i prodotti agricoli si sono rivelati sicuri: gli spazi rurali continuano a funzionare come elemento di ordine e riserva di futuro, piuttosto che come centri di rischio. I risultati del monitoraggio capillare dei suoli e delle produzioni agricole condotto in questi ultimi due anni dicono questo.
In realtà, le aree da mettere in sicurezza sono perfettamente note da un decennio, sono le poche centinaia di ettari (su 140.000 ettari della piana) di pertinenza delle grandi discariche che per un trentennio hanno ingoiato flussi ingenti, legali e non, di rifiuti urbani e speciali. L’unica cosa da fare è quella di mettere in sicurezza una volta per tutte queste ferite, con approccio sobrio e tempi rapidi, restaurando un paesaggio leggibile, di qualità, e affrontando di petto la causa dei problemi, invece di inseguirne i malintesi sintomi. In assenza di ciò, il risultato, per ora, è l’assegnazione per legge all’area napoletana, da parte della comunità nazionale, di un marchio di inaffidabilità a tempo indeterminato.
Resta il fatto che il mosaico rurubano, fatto di spazi vuoti e poveri pezzi città, il paesaggio senza capo né coda, che si coglie dai viadotti che frettolosamente lo attraversano e scavalcano, è l’ambiente nel quale vivono i due terzi della popolazione provinciale, che ha oramai identificato proprio in questo disordine, nella fatica del vivere quotidiano che esso comporta, la principale minaccia alla propria esistenza e al futuro. La crisi della Terra dei fuochi sta tutta qui, nell’atteggiamento di complessivo rifiuto di un habitat percepito come ostile, a partire proprio dalle sue componenti rurali, considerate in un simile contesto alla stregua di vere e proprie fonti di rischio. Una prospettiva da ribaltare completamente, restituendo alle componenti rurali dell’area metropolitana, il ruolo prezioso di green belt multifunzionali, aree preziose di compensazione ecologica e di conservazione del paesaggio.
Curare le ferite
A partire dal 2012 abbiamo partecipato a ecoremed, il progetto LIFE sulla bonifica ecocompatibile dei suoli agricoli contaminati della piana campana, assieme a un’ottantina di ricercatori dell’Università Federico II di Napoli, un gruppo interdisciplinare di agronomi, biologi, chimici, geologi, medici, urbanisti, ingegneri, economisti coordinati da Massimo Fagnano, docente di agronomia presso il Dipartimento di Agraria.
Per cinque anni lo stato di salute degli ecosistemi agricoli della piana campana è stato studiato a fondo, con un check-up approfondito dei suoli, delle acque, della biodiversità vegetale e animale, del paesaggio, ma anche dell’economia, per capire le ferite che la tempesta mediatica della Terra dei fuochi ha lasciato sulla pelle delle aziende e degli agricoltori.
Le ricadute del progetto sono state molteplici. Innanzitutto, il contributo che il progetto ha fornito al governo italiano per l’identificazione delle aree potenzialmente contaminate, e la messa a punto di tecniche di recupero ecocompatibili, basate sull’impiego di piante, microrganismi e compost, che rappresentano un’alternativa concreta a quelle ingegneristiche. In questo modo, con un costo che è un ventesimo delle bonifiche tradizionali, è possibile salvare il suolo, evitandone l’asportazione o la sigillatura, con l’impianto invece di una vegetazione forestale che aiuta anche a ricostruire il paesaggio.
Un’altra ricaduta importante è stata l’applicazione pilota di queste tecniche, già nel corso del progetto, ad aree problematiche della piana campana, con l’impianto di boschi inerbiti dove trentamila pioppi, come instancabili fabbriche verdi, lavorano ora per estrarre i contaminanti e tenere in sicurezza i suoli e l’ambiente di lavoro.
Il terzo aspetto di rilievo è il lavoro di divulgazione svolto nel corso del progetto, con il coinvolgimento di migliaia di studenti, professori, amministratori, agricoltori: una capillare opera di informazione, per chiarire i reali aspetti della crisi della Terra dei fuochi, e le vie di uscita possibili. Le aree pilota del progetto si sono trasformate in un laboratorio, un’aula all’aperto dove gli studenti delle scuole pubbliche della Campania, con i loro docenti, vengono ad imparare come si cura e si recupera un paesaggio malato.
La storia del progetto ECOREMED è singolare, perché per una volta la ricerca scientifica è riuscita ad operare “in tempo reale”, nel pieno della crisi, con i risultati delle attività di studio che sono stati tempestivamente trasmessi ai ministeri competenti via via che venivano prodotti e validati, ed impiegati nella redazione dei due rapporti governativi sulla Terra dei fuochi, quello sulla mappatura dei suoli agricoli, e quello sugli aspetti socio-economici della crisi. Un’altra notazione positiva riguarda la cooperazione istituzionale, perché in tutta questa vicenda i ricercatori hanno lavorato in stretto contatto con le istituzioni, a partire dall’Assessorato regionale all’Agricoltura, che ha affiancato l’università come partner del progetto europeo.
I risultati di cinque anni di lavoro consentono di raccontare una storia molto diversa da quella mainstream di un’agricoltura inaffidabile e senza futuro, produttrice di rischio e malattia. Se c’è una cosa che funziona nella pianura campana, spezzettata da un cinquantennio di crescita urbana senza regole, sono propri gli spazi agricoli residui, che non sono pochi, rappresentando ancora il 65% del territorio complessivo. In queste aree, dei circa diecimila campioni di prodotti ortofrutticoli esaminati, quelli difformi dalla severa normativa europea si contano sulle dita di una mano, per colpa soprattutto del piombo, che non viene dal ciclo dei rifiuti, ma è quello tetraetile delle benzine super di quindici anni fa, che si è depositato, come accaduto in mezz’Europa, nelle fasce agricole più prossime agli assi stradali.
Anche i suoli agricoli potenzialmente contaminati alla fine sono solo una trentina di ettari, sui cinquantamila presi in esame, e per questi ecoremed ha messo a punto tecniche a basso costo per pulirli e metterli in sicurezza utilizzando boschi inerbiti, la cui azione di bio-fitorisanamento è opportunamente stimolata dall’apporto di compost e microrganismi autoctoni. Questi boschi verdi di fitorisanamento funzionano come sentinelle, consentendo il monitoraggio nel tempo del destino dei potenziali inquinanti nei diversi comparti dell’agroecosistema, ma sono soprattutto presidi di civiltà, il segno che lo Stato è ritornato, e che il paesaggio rinasce.
Il bosco più grande, sei ettari, è stato realizzato a San Giuseppiello, a Giugliano, vicino la discarica Resit, in collaborazione con l’ex Commissariato di governo. Qui, al posto della terra di nessuno, è nato un grande parco pubblico con ventimila pioppi. In questo arboreto magnifico la camorra, come accertato dalle indagini della Magistratura, ha scelleratamente interrato per anni fanghi industriali.
Come detto in precedenza, al posto delle tecniche ingegneristiche tradizionali, estremamente costose, e che per di più non consentono di proseguire con l’agricoltura, nel fondo di San Giuseppiello è stata invece completata l’operazione di messa a dimora di ventimila pioppi: un bosco inerbito che lavorerà negli anni, sotto attento monitoraggio, per ridurre la frazione biodisponibile dei metalli ora presenti nel suolo. Negli hot-spot a più elevata concentrazione di inquinanti sono state seminate specie iper-accumulatrici come la Senape indiana (Brassica juncea) che è tra le specie erbacee più efficaci nell’asportare i metalli.
Il costo dell’intervento è stato circa ottocentomila euro, contro venti milioni che sarebbero serviti con le tecniche tradizionali. Con il vantaggio di conservare queste aree all’uso agricolo, di non consumare il suolo, di ricostruire il paesaggio rurale.
L’impianto del bosco è stato preceduto da un monitoraggio capillare, con campionamenti tradizionali e con tecniche radiometriche innovative, delle effettive condizioni di contaminazione dei suoli. Sono state così prodotte mappe dettagliate, che descrivono lo stato di salute dei suoli sia in superficie che in profondità. In questo modo è possibile intervenire adeguatamente punto per punto, in funzione delle effettive condizioni di contaminazione.
Queste indagini hanno consentito di accertare una cosa importantissima: le particolari proprietà dei suoli vulcanici di San Giuseppiello hanno impedito la migrazione verso il basso dei contaminanti somministrati con i fanghi industriali, evitando che arrivino alle falde. Ad ogni modo, il grande bosco verde che si è finito di impiantare verrà scrupolosamente monitorato dai ricercatori dell’Università Federico II, per seguire l’evoluzione di tutti i parametri chimici e biologici.
Si tratta di un approccio estremamente interessante, perché potrà essere esteso agli altri siti della piana campana che hanno gli stessi problemi, con costi compatibili, ricostruendo e mettendo in sicurezza il paesaggio della piana campana. E’ questo un punto molto importante: a San Giuseppiello non si sta solo recuperando la fertilità dei suoli. Si sta anche ricostruendo il paesaggio. Al posto di un sito degradato, c’è ora un bosco verde che rappresenta anche un presidio visibile di legalità: un luogo nel quale grazie all’azione dei poteri pubblici si sta lavorando per rimediare ai crimini e agli errori del passato.
L’obiettivo è quello di curare i suoli agricoli senza distruggerli ed evitando anche di rimuoverli come se si trattasse di un rifiuto speciale da smaltire in discarica. Si tratta quindi di un approccio ben diverso da quello, per riferirsi a un caso molto noto, messo in campo in occasione di Expo 2015, dove cento ettari di suolo contaminato sono stati sepolti sotto una piattaforma di cemento, sulla quale è stata poi allestita l’area espositiva.
Come detto in precedenza, il bosco di San Giuseppiello è un laboratorio verde all’aperto, ma è diventato anche un’aula, un luogo di informazione e divulgazione, per mostrare e raccontare agli studenti delle scuole pubbliche campane, e ai cittadini, cosa si può fare concretamente per curare gli ecosistemi agricoli feriti, per ricreare condizioni di sicurezza e salubrità, per conservare e curare i suoli feriti di Campania felix.
Conclusioni
La “Terra dei fuochi”, con tutte le sue difficoltà, è stata alla fine anche l’occasione per una riflessione laica, senza slogan e infingimenti, sulle politiche ambientali in Italia, e sulla capacità del nostro apparato legislativo e amministrativo di progettarle e implementarle. È necessario riflettere seriamente sul perché, uno spazio rurale metropolitano, pure dominante dal punto di vista dell’estensione territoriale, alla fine sia diventato trasparente alle politiche pubbliche, assieme ai suoi abitanti, finendo per trasformarsi in uno “spazio vuoto”, un’area di risulta priva di valori specifici, nella quale un sistema urbano fuori controllo può vomitare tutti i suoi problemi ed esternalità.
Il dramma della Terra dei fuochi è tutto qui: la sua collocazione in un’area metropolitana, la terza del paese, ancora priva di un sistema minimo di governo del territorio, di una strategia pubblica in grado di restituire senso e coerenza ad un mosaico scombinato di realtà urbane sofferenti e di poveri pezzi di campagna.
La protesta degli abitanti della Terra dei fuochi – i due milioni di cittadini che popolano l’hinterland metropolitano di Napoli – parte da qua, da un ambiente di vita avaro di opportunità, vissuto come incerto e ostile, nel cui disordine anche gli scampoli di ruralità finiscono per essere percepiti, anziché come risorsa, come fonte di rischio. Se tutto questo è vero, ciò di cui ha disperatamente bisogno la cosiddetta Terra dei fuochi, non sono le bonifiche, anche necessarie, e reclamate a gran voce dell’arcipelago di comitati, che della crisi ambientale hanno fatto una questione identitaria, quanto le politiche.
A questo punto, la missione è piuttosto quella di ristorare i paesaggi, mettere finalmente ordine in un mosaico territoriale fuori controllo; dotare questo sistema congestionato di standard minimi di civiltà, ricreando un ambiente sicuro e attrattivo per i cittadini come per le aziende. In tutte queste cose, si è visto, lo spazio rurale non rappresenta il problema, quanto piuttosto la risorsa dalla quale partire per ricostruire un paesaggio di vita credibile. Sono cose che riguardano la dissestata filiera dei poteri, da quelli locali fino al governo centrale, maledettamente più impegnative degli interventi placebo messi in campo per arginare la tempesta mediatica degli ultimi anni.

Michele Serra, Repubblica del 19 dicembre 2019
«Le aziende non sono solo realtà economiche ma anche organismi sociali. Non vanno giudicate solo dai profitti, ma anche misurando effetti negativi e costi esterni. Calcolando i danni ambientali che creano o quanto promuovono inclusione e giustizia sociale». Chi parla così non è un neomarxista alla Piketty. È uno dei guru del capitalismo mondiale, l’ottantunenne Klaus Schwab, fondatore del World Economic Forum di Davos, intervistato da Ettore Livini.
Viene spontaneo domandarsi come mai un mondo ultra-dinamico e per giunta molto facoltoso (con fior di centri studi a disposizione) stia arrivando nel 2020 a conclusioni alla portata di molti già alla fine del secolo scorso, prima che accadesse l’irreparabile: ovvero che le gran parte delle aziende NON agissero come organismi sociali, giudicassero se stesse solo in base ai profitti, si guardassero bene dal calcolare costi esterni e ricaduta sociale delle loro azioni.
Questo lascia sospettare che tanto il signor Schwab quanto la moltitudine di manager e consulenti di quello che chiamiamo, con necessaria approssimazione, capitalismo, anche quando umanamente atteggiati al meglio, hanno avuto zero possibilità di correggere la rotta.
Il Capitale descritto da Marx come un’entità quasi sovrumana, dotato di meccanica propria, “intelligenza” propria, evidentemente esiste.
Mica rileggersi quel tremendo mattone che è Das Kapital in edizione integrale, per carità. Ma un buon gadget per gli ospiti del prossimo Forum di Davos, oltre alla bottiglia di champagne in camera, sarebbe quel prezioso bigino che è il “Compendio del Capitale” dell’anarchico pugliese Carlo Cafiero. Il libretto è del 1879, ottima annata anche per lo champagne.
IFORD, Altracittà e l’associazione culturale “Laura Lombardo Radice” hanno organizzato la presentazione a Roma di “Ultime notizie”, il prossimo 29 novembre alle 20.00, presso Il Seminterrato di Via Siena, in Via Siena 2. Intervengono Francesco Erbani e Peter Hoogstaden. L’occasione per ragionare ancora insieme su una strategia per lo spazio rurale italiano.
Antonio di Gennaro, Repubblica Napoli del 5 aprile 2019
Torna da Milano a Napoli e nell’area vesuviana Maria Pace Ottieri, per ragionare e discutere ancora del suo libro “Il Vesuvio universale”, pubblicato da Einaudi nella collana “Frontiere”, che è semplicemente il più importante reportage sull’area metropolitana realizzato in questi anni, scegliendo come baricentro il vulcano più famoso al mondo.
Il libro è un reportage impeccabile, di grande scrittura, ma è anche un romanzo che ti prende, anzi, un agglomerato incredibile di storie che crescono e germogliano l’una sull’altra, perché Maria Pace ha letto e studiato tutto, e d’ogni cosa ti racconta con precisione e leggerezza genesi ed evoluzione, si tratti di Maiuri e degli Scavi di Ercolano, del baccalà di Somma Vesuviana, o dell’ascesa e declino industriale di Torre Annunziata. La Ottieri cammina, viaggia in metro e Circumvesuviana, incontra persone e le interroga, ne registra i racconti, si immerge nelle atmosfere. Il suo metodo è simile alla “osservazione partecipante” degli antropologi, e ciò che vien fuori, ha ragione Giovanni Gugg, è anche un raffinato saggio di etnografia.
Quello che colpisce, e convince, è il fatto che lo stesso metodo Maria Pace lo applichi con ammirato stupore agli aspetti irriducibili di bellezza dei contesti storici e naturali, per quanto affaticati e sciupati dal tempo; come a quelli desolati dell’abbandono e dell’anomia, si tratti del disordine della crescita edilizia sgovernata, che è poi la madre di tutti i rischi; delle cave nel Parco del Vesuvio trasformate in discariche, dei tessuti urbani che marciscono, o delle povere aree agricole mortificate dal caos. Pure in queste situazioni, la Ottieri rifugge i giudizi sommari, studia, si documenta, continua a discutere, a farsi spiegare e raccontare, si sforza di capire la vita dei luoghi e delle persone, anche quando si vede che non ne avrebbe forse la voglia.
Certo il protagonista rimane lui, il Vesuvio, e il libro è una miniera di informazioni sulla storia e l’attività del vulcano misterioso, del quale pensiamo di saper tutto, ma la cui natura profonda ancora ci sfugge, come il suo profilo, che si rinnova e muta appena cambi punto d’osservazione. C’è una vulcanologia minuziosa che fa da sfondo a tutta la narrazione, oltre a costituire la motivazione genetica della precarietà che da duemila anni segna la vita delle persone e delle città. “Il vulcano” scrive la Ottieri “allena i suoi abitanti a vivere in una vacillante realtà sempre sull’orlo della dissolvenza, della metamorfosi, a riempire il vuoto al centro, il cratere della vita di ognuno, con l’immaginazione, trovando nell’invisibile il senso più vero dell’essere al mondo.”
E’ venuta una scrittrice da Milano a metterci davanti agli occhi con acutezza e sincerità la sostanza del nostro intricato vivere metropolitano, per quello che è, senza infingimenti, cogliendone le dimensioni e stratificazioni nascoste, ma una spiegazione forse c’è. All’inizio del libro Maria Pace racconta come il Vesuvio e l’idea di scriverlo le siano apparsi “… una mattina all’alba nel dormiveglia, quello stato anfibio in cui i pensieri sommersi si affacciano alla coscienza”. E’ un ricordo affiorante d’infanzia del 1955, lei era nata da poco e il papà, lo scrittore Ottiero Ottieri, lavorò per un anno nello stabilimento appena inaugurato dell’Olivetti a Pozzuoli, all’altra estremità del Golfo. Nell’universo complesso e profondo di Maria Pace evidentemente una traccia è rimasta dell’umanesimo riformatore di quell’esperienza all’inizio della vita, il guardare al mondo come alla casa degli uomini, un posto da comprendere, mai maledire, se possibile migliorare.
Le presentazioni de “Il Vesuvio universale” con Maria Pace Ottieri si terranno il 5 aprile a Castellammare di Stabia al Salone Viviani (Cappella sant’Anna, Vico Sant’Anna); il 6 aprile a Napoli, presso Eccellenze Campane; l’8 aprile ancora a Napoli, alla libreria del Teatro Bellini; il 9 e il 10 aprile a Ercolano, presso le Scuderie della Villa Favorita; l’11 aprile a Vico Equense, Libreria Ubik.
Antonio di Gennaro, 13 marzo 2019
Prefazione al libro di Luigi d’Aquino e Francesco Paolo Innamorato:
I sistemi agricoli dell’Agro Nocerino. Ascesa e declino di un paesaggio culturale – YOUCANPRINT, 2019
Il libro che vi apprestate a leggere è un piccolo gioiello. Attorno al nucleo originario, costituito dall’analisi del territorio agroforestale di Nocera Inferiore effettuata per la redazione del nuovo piano urbanistico comunale, Luigi d’Aquino e Francesco Innamorato hanno costruito un racconto complesso degli ecosistemi e dei paesaggi dell’Agro Nocerino Sarnese, che affascina e sorprende come un romanzo. Dico sorprende perché il lavoro che i due autori svolgono autorevolmente da decenni è eminentemente scientifico, Luigi nel campo della ricerca e sperimentazione in agricoltura; Francesco in quello dell’analisi dei sistemi territoriali. Quello che ti aspetteresti allora è una rigorosa pubblicazione specialistica sugli aspetti agricoli e agronomici di un territorio assolutamente unico, quello dell’Agro, per il quale, nonostante il ruolo determinante avuto nella storia della Campania, ancora mancano studi d’insieme specifici.
Tutto questo indubbiamente nel libro c’è, ma è solo l’inizio del racconto. La descrizione delle terre, degli ecosistemi e dei paesaggi dell’Agro, mirabilmente compiuta dai due autori, diventa infatti lo scenario per la narrazione del divenire storico, nell’arco di due millenni, di una comunità locale, della sua economia e cultura, degli equilibri sociali. Se la storia raccontata nel libro è quella di un mutamento drammatico – lo sconvolgimento nell’arco di un paio di generazioni della porzione più pregiata di Campania felix, trasformata nella latitanza dei pubblici poteri in una conurbazione disordinata, segmento disperso di un sistema metropolitano fuori controllo – lo sforzo degli autori è quello di evidenziare il complesso di forze e processi che, nel contesto ecologico dato, questo mutamento hanno prodotto.
Se il libro si legge come un romanzo c’è pure un altro motivo, ed è il legame profondo che lega i due autori alla terra e al paesaggio oggetto della loro analisi e del loro racconto, che è tutt’altro che asettico, e vibra invece in ogni frase di un amore e di uno sdegno che essi non sono proprio in grado di celare. Oltre alle competenze specifiche, c’è un’energia che anima tutta la storia, che deriva dal fatto che Luigi d’Aquino e Francesco Innamorato vivono la loro professione, ne siano consapevoli oppure no, come una forma di impegno civile, quella che Manlio Rossi-Doria chiamava “la politica del mestiere”.
Allora è bello abbandonarsi al racconto che Luigi e Francesco ci propongono, in un esplorazione scientifica e culturale che comprende le rocce, il clima, il suolo, ma anche l’architettura rurale e la storia dell’insediamento, i progressi tecnici, i conflitti sociali, fino al racconto dell’ascesa e caduta della filiera agroindustriale gloriosa del pomodoro, un’eccellenza di scala mondiale che non abbiamo saputo proteggere, e che finisce col diventare l’emblema di una dinamica di declino territoriale che pare inarrestabile.
E’ una conoscenza complessa quella che gli autori ci propongono, che deriva dalla sintesi di saperi diversi, agronomici, storici, sociali, economici. Pure, è grazie a letture come questa, anche nei risvolti più amari, nel rimpianto per un futuro possibile che non è riuscito a imporsi, che una nuova consapevolezza può essere recuperata. Delle terre, ecosistemi e paesaggi che sono i protagonisti del libro molto rimane ancora da proteggere. Nonostante gli errori, non tutto è perduto, una porzione rilevante del patrimonio millenario ancora permane, ed è merito di questo libro quello di indicare ancora una strada.
Ugo Leone, Repubblica Napoli del 23 febbraio 2019
Chi ha avuto la fortuna di leggere già nelle pagine napoletane della “Repubblica” i reportage di Antonio di Gennaro, leggendone la raccolta in volume (“Ultime notizie dalla terra” Ediesse edizioni) può solo raddoppiare il piacere. Anche perché in questo nuovo libro oltre gli articoli usciti in quelle pagine tra aprile 2016 e luglio 2018, vi sono anche due inediti: «Il paesaggio perduto dell’Asprinio» e «Sotto il vulcano».
Quest’ultimo chiude il volume e mi piace cominciare proprio dalla fine le riflessioni che la lettura mi ha suggerito. Quando ho letto “il vulcano” ho pensato immediatamente al Vesuvio. E invece no. È il Roccamonfina, il “gigante addormentato” dove faticosamente lavora Zeb Macahan su sei ettari di mele annurche.
Comincio dalla fine perché queste “ultime notizie” sono anche un avvertimento: stiamo attenti perché da questa regione, dalla Campania, come dal resto del Mezzogiorno, non se sta andando solo la gente, ma corre seri rischi anche l’abbandono dell’agricoltura.
È un rischio serio e preoccupante, come nota anche Ottavio Ragone nella sua prefazione. Perché, specialmente nelle aree interne della regione, lo spopolamento di interi paesi provoca anche l’abbandono del lavoro nei campi e la conseguente espansione delle terre incolte. Sono i giovani, naturalmente, ad andarsene alla ricerca di migliori, meno faticose e più remunerative occasioni di lavoro.
Questa è la tendenza e il rischio che diventi la regola. A meno che… L’ ”a meno che” è la speranza che consente di nutrire la lettura di questo libro. Perché di Gennaro che è un agronomo e un acuto conoscitore della cartografia dei suoli, scrive cose e racconta fatti che aprono il cuore alla speranza. E speranza prima è che la loro lettura apra anche le menti di chi ha il potere e il dovere di trasformare in fatti concreti quella speranza.
Per cominciare Antonio di Gennaro riporta nella giusta dimensione geografica e quantitativa l’annoso “subdolo” problema noto come “terra dei fuochi”. Arrivando, dopo anni di lavoro con una équipe di un centinaio di studiosi, a monitorare lo stato di salute dei suolo della pianura campana mettendo insieme una base di migliaia di dati analitici “come non esiste in nessun’altra area agricola d’Europa” e tali da scagionare l’agricoltura della grande pianura vulcanica.
Una conclusione tale da far crollare “lo schema ferreo raccontato dai media”. Ma, commenta amaramente, “le ferite rimangono”. E rimangono perché non è il cane che morde l’uomo che fa notizia, ma l’uomo che morde il cane. Ed è secondo questa logica di una parte dell’informazione e degli informatori che quanto accaduto e accade nella terra dei fuochi è stato mediato fino a far coincidere la ristretta area tra le province di Napoli e Caserta, con l’intera regione. Tanto da scoraggiare gli acquirenti di frutta e verdura dall’acquistare prodotti campani. Quando mi è capitato di scriverne ho ricordato più volte una importante trasmissione radiofonica (“tutta la città ne parla”) dedicata alla terra dei fuochi nella quale un ascoltatore padovano telefonò per dire: “sono un vegetariano e quando vado dal fruttivendolo mi assicuro che frutta e verdura non vengano dalla Campania”.
Ma, come di Gennaro aveva già scritto qualche anno fa, “La Campania non è una terra maledetta”. E lo dimostra, con una forma che dà particolare evidenza e rilievo alla sostanza, nella serie di reportage contenuti in questo libro. Tante storie, dai grani antichi dell’Alta Irpinia ai coltivatori delle fragole e del pomodoro San Marzano; dai coltivatori vesuviani del Pomodorino del piennolo, agli allevatori della Marchigiana e delle bufale; dagli olivocoltori delle colline del Cilento, a quelli della Penisola sorrentina “che coltivano i terrazzi antichi a precipizio sull’azzurro”; dai viticoltori dei grandi vini del Sannio a quelli del recuperato Asprinio a quelli “solitari che curano vigneti centenari in piena città di Napoli”. Storie che, come di Gennaro ama notare, si imperniano tutte su una triade: il paesaggio, l’imprenditore agricolo, il prodotto.
Ne risulta un eccezionale mosaico di biodiversità e paesaggi rurali, degli ecosistemi insomma, che sono l’identità campana. Un mosaico che dovrebbe essere sufficiente a promuovere il rilancio dei prodotti agricoli della regione. E a diffondere il messaggio che anche in Campania l’agricoltura può costituire una risorsa economica capace di produrre anche lavoro e di trattenere la fuga dalla campagna.
Ma, invece, non basta. Perché –questa un’altra importante riflessione dell’autore – occorre che le persone dispongano “di conoscenze corrette sui processi di produzione agricola, sul funzionamento dei paesaggi e degli ecosistemi nei quali tali attività si compiono; nozioni che dovrebbero far parte del bagaglio di base di ogni cittadino, senza le quali è oggettivamente difficile farsi un’idea fondata sulla sicurezza e la qualità dei prodotti che arrivano ogni giorno sulla mensa.”.
E “le persone” dovrebbero essere innanzitutto i responsabili delle sorti della cosa pubblica. I quali se se lo leggessero questo libro troverebbero non poco giovamento nell’inquadrare nella giusta direzione le politiche agricole del Paese Italia e della regione Campania.
Il libro verrà presentato sabato 23 febbraio 2019 alle ore 18.00 alla Libreria Imagine’s Book, in C.so Garibaldi 142 Salerno; martedì 26 febbraio 2019 ore 17.30, all’Enoteca provinciale, in Via Cesare Battisti 48, Caserta; venerdì 8 marzo 2019, ore 17.30 presso la sede di Futuridea – Associazione per l’innovazione utile e sostenibile, Contrada Piano Cappelle, Benevento; mercoledì 10 aprile 2019, ore 16.00, preso l’ Istituto di studi sulle società del Mediterraneo, in Via Guglielmo Sanfelice 8, Napoli; venerdì 12 aprile 2019, ore 19.00, alla Libreria Verso, in corso di Porta Ticinese 40 , Milano.
Si inizia sabato 23 febbraio a Salerno, poi martedì 26 a Caserta, e poi ancora Benevento, Napoli, Milano…
Ecco l’elenco delle presentazioni programmate sinora:
– sabato 23 febbraio 2019 alle ore 18.00 alla Libreria Imagine’s
Book, in C.so Garibaldi 142 Salerno;
– martedì 26 febbraio 2019 ore 17.30, Enoteca provinciale, Via
Cesare Battisti 48, Caserta;
– venerdì 8 marzo 2019, ore 17.30, Futuridea – Associazione per
l’innovazione utile e sostenibile, Contrada Piano Cappelle,
Benevento;
– mercoledì 10 aprile 2019, ore 16.00, ISSM – Istituto di studi
sulle società del Mediterraneo, Via Guglielmo Sanfelice 8
Napoli;
– venerdì 12 aprile 2019, ore 19.00, Libreria Verso, corso di
Porta Ticinese 40 , Milano.






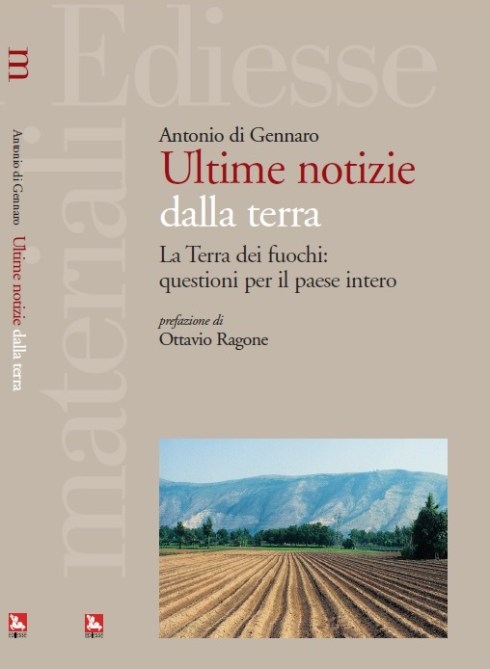
Commenti recenti